RACCONTI
I cumpari i San Giuvanni – L’uomo Cane – Un’azione disonesta – Il garzone – L’emigrante – L’albero dei millecucchi – U’ zu Paulu Marredda – Storie d’altri tempi – Lu pani cu li favi
PRESENTAZIONE
 Come gli studiosi di narratologia sanno, ogni racconto si dispone su un piano mitico e mitiche sono le sue strutture.
Come gli studiosi di narratologia sanno, ogni racconto si dispone su un piano mitico e mitiche sono le sue strutture.
I sostenitori del realismo letterario contestano questa opinione; talora anzi assumono pagine o interi romanzi quale documento di verità storiche. Se per storia noi intendiamo solo il corso degli eventi nel loro tempo e come sono stati e sono rappresentati i realisti hanno sicuramente ragione.
Questo concetto di storia nasconde tuttavia un errore, quello cioè che i livelli dell’accaduto, del vissuto e del rappresentato siano omologhi o isomorfi. Il flusso esistenziale, individuale o collettivo e le sue proiezioni rappresentative, che sono sempre narrative, in realtà obbediscono a logiche diverse. La riduzione rappresentativa del vissuto è sempre diversa da questo tanto in senso orizzontale quanto verticale. Il vissuto è un unicum continuum, come tale non èp mai in esso individuabile un convincimento e una fine, inoltre non è mai determinabile il numero dei piani in cui si articola. Al contrario il narrato ha sempre un principio e una fine e il numero dei piani dell’esistere che non riesce a contenere è sempre ridotto.
Il vissuto è scandito da ritmi temporali impliciti, il narrato da ritmi espliciti. La rappresentazione del vissuto in ritmi espliciti e organizzati, finisce in realtà con l’estrapolare gli eventi dal flusso del tempo cronologico, proiettandoli in una dimensione senza passato, presente e futuro, la dimensione appunto che costituisce lo specifico dei miti..
Una significativa verifica di quanto sto osservando viene dai racconti di Salvatore Maurici. Apparentemente essi rappresentano nella loro drammaticità frammenti della realtà, di una certa realtà, della nostra isola. Di fatto essa viene rivissuta e rappresentata in termini mitici. Si scorrano per esempio, le immagini conclusive del racconto “L’emigrante”, uno stupro collettivo, scenario quanto mai crudo e drammatico, si stempera e diluisce nella memoria di persone e paesi lontani, presentificati com in una fiaba: una dimensione mitica che solo chi ha il dono di saper raccontare, come Maurici, è capace di far rivivere.
Nino Buttitta
RACCONTI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Se un giovane passa vicino ad un qualsiasi capannello di ciarlieri sambucesi, a costui potrà capitare di ascoltare molte e coloratissime discussioni fra vecchi amici, i quali spesso trattano di fatti straordinariamente fantasiosi, e costoro vogliosi di stabilire il gruppo degli ascoltatori sono portati ad esagerare i propri racconti rendendoli alquanto misteriosi.
Racconti e fantasie dell’antica terra di Chabuca su cui i nostri vecchietti amano prendere lo spunto per innestarvi la propria fervida fantasia. Fra questi, i “Cumpari i San Giovanni” sono appunto fra i più fantastici.
È da precisare che quasi tutti gli anziani sollecitati sull’argomento ti forniscono in men che non si dica la propria storia sui lupi mannari, ma è certo che la fantasia che ci raccontava lo zio Vito al proposito era fra le più terrificanti.
“Dunque” – era solito cominciare il discorso quel simpatico personaggio che un bicchiere di vino generoso di Pandolfina aveva fatto diventare allegro e gioviale; era il suo preambolo prima di ogni lunga narrazione, mentre pigiava con abilità due-tre pezzi di “spuntatura” nella sua pipa di terracotta, accendeva, e dopo avere tirato un paio di boccate avide, riprendeva il discorso: – Al tempo in cui è accaduta questa storia alquanto strana, ero ancora un ragazzino. Abitavo a quel tempo nella vecchia casa paterna sita fra “li setti vaneddi, proprio vicinu la chiesa di lu Rusariu”, P. madonna…, figliuolo è tempo che tu la smetta di guardarmi con quel sorrisetto da ebete, non sono ancora rincoglionito come mi pare tu stai pensando, al punto da suscitare il tuo compatimento.
L’interpellato evidentemente colto in fallo si confuse, arrossì, mormorando qualche parola incomprensibile allo zio Vito che i più interpretarono come una scusa, poi riprese ad ascoltare il vecchietto con qualche linea in più di interesse per i fatti che via via egli andava udendo.
– A quei tempi lavoravo come aiuto-pastore presso “Lu Cavaleri Ingrisi” e fra quegli immensi feudi della Gran Montagna trascorrevo intere giornate a correre dietro immensi greggi di pecore, ad accudirli, a custodirli.
– Doveva essere dura, allora, vero zio Vito? – chiese il ragazzo di poco prima, sperando di farsi perdonare con la sua accondiscendenza – ed il vecchio infatti mostrò di gradire assai quell’attenzione.
– Infatti – mormorò quasi con soddisfazione – per noi giovani allora era molto dura, non c’erano soldi in casa, né i divertimenti che avete a disposizione voi ragazzi oggi, anche se consentimi di dire che allora noi forse eravamo un pò più uomini…
– É questo adesso cosa c’entra con il discorso di prima? – il ragazzo di prima adesso cominciava a mostrare risentimento.
– C’entra, c’entra – il vecchio dondolò il capo in modo affermativo, ma talmente forte che coloro che gli stavano attorno ebbero quasi la sensazione che quella boccia rotonda e lucida, appena circondata da una leggera corona di peli bianchi fosse già lì per lì per ruzzolare a terra. Fortunatamente per il legittimo proprietario essa rimase alla fine ferma al suo posto, anche se continuò a rollare con un movimento appena percettibile.
– Ero venuto come tante altre volte in paese per la mia giornata di riposo (la vicenda), trascorsi l’intero pomeriggio a passare e ripassare per una stradina che so io, nella speranza che una certa ragazza si facesse viva (e così dicendo, in segno di godimento, si lisciò i grossi baffi ammiccando con aria complice a coloro che gli stavano più d’appresso), sul fare della sera, infine mi recai con alcuni amici presso una taverna a far baldoria e lì rimasi fino a notte fonda.
Ritornai a casa che era mezzanotte passata, così decisi di mettermi in viaggio per ritornare sù in montagna, sellai la giumenta, posi nelle bisacce una buona scorta di viveri e mi avviai per la trazzera che conduceva ai pascoli d’inverno, verso la montagna. Presto anche la trazzera si disperse in tanti piccoli viottoli che si inerpicavano faticosamente per le montagne diretti ognuno verso il proprio marcato, viottoli molto stretti ai lati dei quali ogni tipo di erbaccia solitamente striminzita, cresce rigogliosa e ciò induceva chiaramente a pensare come tali luoghi fossero frequentati soltanto da sparuti viandanti e dagli stessi animali che dimoravano in quelle contrade.
Una pallida luna rischiarava appena il paesaggio aumentandone così agli occhi degli uomini il senso di mistero e di immensa solitudine.
L’animale conosceva bene la strada da fare, ed io abbandonate le redini sul collo della giumenta, sognante fui preda dei pensieri più strambi e fantastici, forse un riflesso delle strane storie che aveva raccontato un mio conoscente proprio durante la serata trascorsa con lui alla taverna, e che a pensarci bene mi rafforzava nell’idea che dette storie fossero state suggerite dall’eccessivo numero di bicchieri di vino che l’uomo in questione aveva bevuto quella sera.
Erano davvero incredibili le storie a proposito delle trasformazioni di uomini in bestie specie durante le notti di luna piena. Sorrisi fra me e me a quelle stramberie pur tuttavia non potei frenare uno sguardo preoccupato alla luna piena; non potei fare a meno di portare la mano destra verso la cintola dove ero appeso un acuminato pugnale, ne ricavai un piacevole senso di benessere.
Il vino bevuto con gli amici, ed il movimento altalenante della bestia mi conciliavano il sonno, tanto che finii per addormentarmi ben equilibrato sul basto della giumenta, improvvisamente, l’animale scartò nitrendo impaurita ed io preso alla sprovvista finii per ruzzolare a terra. Mi alzai pieno di ammaccature e con molti lividi in ogni parte del corpo e nel frattempo davo un’occhiata attorno. Vidi alcuni alberi di leccio ed anch’essi con la loro immobilità contribuivano ad aumentare il silenzio spettrale del momento. Improvvisamente quel silenzio fu interrotto da un fruscio di rami smossi alle mie spalle; mi voltai e fu così che lo vidi per la prima volta: stava fra il varco di due grossi alberi, fermo, in curiosa attesa, un essere demoniaco, un minimo rumore lo avrebbe certo scatenato contro di me.
Ero completamente paralizzato, quella vista così improvvisa, così orrenda, provocava nel mio corpo l’espulsione di una miriade di piccolissime goccioline di sudore che si attaccavano ai vestiti, oppure sulla fronte scivolavano con esasperante lentezza lungo il collo, poi ancora giù qualcuna di esse, veniva ad inumidire le labbra, ed il loro sapore acidulo aumentava ancora di più il disagio, la paura per quella situazione che ancora in quel momento mi riusciva difficile accettare come reale.
Il mostro era ad una distanza di appena sei, sette metri, continuava a fissarmi in curiosa attesa, era molto alto, circa un metro ed ottanta, dalla cintola in su era un lupo, dalla bocca spalancata, si notavano chiaramente i lunghi canini che a causa del loro candore brillavano nella penombra tanto che aumentavano ancora di più in me il senso di smarrimento e di paura, Il pelo lungo e foltissimo finiva per scomparire completamente nella rimanente parte del corpo dove s’intravedeva la sua appartenenza al genere umano. Un mostro dunque, una figura irreale e tremenda, e mentre cercavo di reagire a me stesso ripetendo continuamente che tutto ciò era un terribile incubo che presto sarebbe finito, ecco che la figura demoniaca dopo aver lanciato un forte ululato si decise a venire avanti.
Per un attimo ebbi la sensazione che tutte le vene del mio corpo si fossero aperte e che il sangue ne uscisse a fiotti, ma fortunatamente per me ciò fu un’impressione passeggera. Forte ed improvviso sentii il desiderio di vivere, facendomi coraggio portai decisamente il pugnale ben stretto in mano in posizione offensiva contro il lupo-mannaro che ormai mi era addosso. Vibrai un primo colpo alla cieca, colpendolo appena di striscio sulla spalla sinistra, mi preparavo a vibrarne un altro, così alla cieca, quando ecco che come per un miracolo il mostro abbandonò la presa allontanandosi di qualche passo. Ed ecco che sotto i miei occhi pieni di folle terrore, accadde l’incredibile. Il corpo peloso ed animalesco prese a trasformarsi, i guaiti di dolore cominciavano a somigliare a singhiozzi umani. Terrorizzato, ormai folle di paura, abbandonato il pugnale per terra, feci continuamente il segno della croce pregando Dio e tutti i santi perché mi usassero la loro infinita misericordia e battendomi il petto mi pentivo di tutti i peccati che avevo commesso nella mia vita, ero ormai convinto di essere nell’anticamera dell’inferno. Non appena l’essere infernale assunse le definitive sembianze umane lo rassomigliai a un nostro paesano che avevo notato diverse volte durante l’ultima festa della Madonna dell’Udienza.
Come dire, se è ancora in vita? no, è morto ormai da qualche anno, sia pace all’anima sua.
Più tardi quando ambedue ci fummo un po’ tranquillizzati egli mi spiegò in breve la sua strana trasformazione. Mi disse che gli era stata fatta una fattura da parte di una donna che lui aveva rifiutato di sposare, ed ancora, che io da quel momento avrei potuto contare sulla sua vita e sulla sua fortuna, perché ormai tutto di lui mi apparteneva tanta era la riconoscenza che egli provava per me.
I0 per la verità ebbi in seguito ad approfittare qualche volta di questa abnorme situazione, d’altra parte ciò era ben poca cosa se paragonato alla grande paura provata al momento in cui mi ero imbattuto nel licantropo, così di seguito ho saputo come quella strana trasformazione veniva chiamata dagli studiosi. Un mese dopo tutti e due ci recammo presso la zachia di S. Giovanni dove assieme ad altri amici festeggiammo la nascente amicizia. Da allora prendemmo a chiamarci “Cumpari i San Giuvanni” – Così lo zio Vito terminò la sua storia che oggi ha più il sapore di una favola.
La licantropia viene ancora considerata come una malattia di carattere nervoso che spinge un uomo a mugugnare come un lupo durante le notti di luna piena. Tutti però sono concordi nel sostenere che il soggetto conserva le sembianze primitive. La licantropia fu molto comune nel 600-700. Il mito del lupo mannaro originario di antiche credenze popolari (se ne trovano tracce anche nel Satyicon di Petronio), pur non avendo mai avuto una grande diffusione nella letteratura gotica, ha tuttavia raggiunto la sua massima espansione nel cinema (stereotipo), il contagio per morso, la trasformazione resa inevitabile nelle notti di luna piena, la soppressione del mostro dominante della bestialità come simbolo delle forze incontrollabili dell’istinto. La prevalenza e la separazione in un uomo della forza del maligno su quello divino. Motivi dunque difficili ed incomprensibili spesso accompagnati da riti magici.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 Mazara è un’animosa cittadina del trapanese, la sua popolazione è dedita con uguale bravura, sia alla coltura dei vigneti da cui si ricavano famosi e pregiati vini e sia alle attività marinare. La flotta peschereccia mazarese, grazie anche all’intraprendenza di alcuni e coraggiosi armatori, è diventata negli ultimi tempi una delle più forti dell’intero Mediterraneo. Pescherecci di questa marineria lasciano quotidianamente il porto-canale sul fiume Mazzaro per andare incontro al mare aperto, veri ed unici padroni di esso. L’intrapendenza dei marinai di Mazzara, il loro grande numero, la grande sete di guadagno li spinge spesso molto vicino alle coste africane, a volte in aspro contrasto con i governi locali di quei paesi che mal tollerano quelle presenze. La popolazione mazarese è molto libera, i suoi figli più giovani amano godere la vita con spontaneità e se ancora esiste fra loro un sentimento classista verso quei coetanei che hanno pochi soldi, ciò non è un fattore decisamente discriminante da turbare i loro incontri di amichevole spensieratezza.
Mazara è un’animosa cittadina del trapanese, la sua popolazione è dedita con uguale bravura, sia alla coltura dei vigneti da cui si ricavano famosi e pregiati vini e sia alle attività marinare. La flotta peschereccia mazarese, grazie anche all’intraprendenza di alcuni e coraggiosi armatori, è diventata negli ultimi tempi una delle più forti dell’intero Mediterraneo. Pescherecci di questa marineria lasciano quotidianamente il porto-canale sul fiume Mazzaro per andare incontro al mare aperto, veri ed unici padroni di esso. L’intrapendenza dei marinai di Mazzara, il loro grande numero, la grande sete di guadagno li spinge spesso molto vicino alle coste africane, a volte in aspro contrasto con i governi locali di quei paesi che mal tollerano quelle presenze. La popolazione mazarese è molto libera, i suoi figli più giovani amano godere la vita con spontaneità e se ancora esiste fra loro un sentimento classista verso quei coetanei che hanno pochi soldi, ciò non è un fattore decisamente discriminante da turbare i loro incontri di amichevole spensieratezza.
Lo sviluppo urbanistico della città, negli ultimi anni è stato abnorme, ma la parte viva ed importante di essa rimane ancora il vecchio centro storico ed in particolare quel lungo serpentone che a partire dalla Cattedrale si snoda per la città vecchia, Via Garibaldi è il centro nevralgico di Mazzara, in essa si trovano i negozi più belli ed esclusivi, lì s’incontrano gli amici, ci si fidanza in questa strada. In questo salotto delle vanità, Mazzara mette in bella mostra la ricchezza raggiunta o ereditata dai propri figli. I gioielli, le pellicce sfoggiate durante la rituale passeggiata serale, vengono valutati e chiacchierati da occhi esperti ed invidiosi.
In questo ambiente visse fino agli inizi degli anni settanta l’Uomo Cane.
Chi era costui che veniva comunemente identificato con un aggettivo tanto deleterio? Per il locale Commissariato di Polizia, mendicante dalla barba e dai capelli lunghi e canuti ad eccezione dei peli che gli circondavano le labbra, imbiondite dalla nicotina del molto tabacco fumato. Un uomo non pericoloso che al momento in cui era in giro per elemosinare, se ne stava tranquillamente sdraiato in un cantuccio al sole nei pressi della Cattedrale se in estate, oppure sotto i portici allorché la pioggia invernale batteva impietosa sugli uomini e sulle cose.
Per i mazaresi la figura dei questo povero mendico, rappresentava qualcosa di più complesso, egli era il protetto di San Vito, loro protettore, amico dei cani e dei mendici, agli occhi della cittadinanza, l’uomo vestito di panni stracciati, rappresentava la punizione divina che scendeva a colpire inesorabile i miseri di cuore, i superbi. E tutti i mazaresi, caso più unico che raro, non provavano ribrezzo per l’Uomo Cane, ma compassione, afflizione anziché indifferenza per la condizione miserevole che quell’essere umano conduceva giorno dopo giorno.
Essere misterioso possiamo definirlo, parlando a proposito del povero di Mazara, ed in verità tutto il comportamento che il nostro uomo teneva nei lunghi e tristi giorni della sua esistenza lo era per davvero. Negli anni trascorsi a Mazara molte furono le persone che tentarono cn ogni mezzo di trarlo dalla sua infelice condizione, ma senza alcun risultato. Giorno dopo giorno egli continuò la sua vita con ossessionane meticolosità accettando il pane che gli offrivano sempre e soltanto se questo veniva deposto per terra, mostrandosi offeso se l’esistente benefattore non desisteva dai suoi proponimenti. Per questa sua testarda volontà la gente, prese a chiamarlo l’Uomo Cane, con tale appellativo divenne talmente conosciuto nella come unità che non vi era mazarese che non fosse a conoscenza della sua esistenza e che non ne parlasse di tanto in tanto.
Il nostro misterioso uomo faceva delle eccezioni suo comportamento soltanto per le sigarette ed anche qui come delle stranezze. Fumatore incallito, egli le accettava direttamente dalle mani dei molti studenti che a volte lo circondavano incuriositi ed affascinati dallo strano individuo, purché costoro avessero avuto l’accortezza di mormorare la frase rituale: “Hai piacere a dividere con me le mie sigarette?” Il viso dell’uomo allora prendeva ad essere irradiato da una luminosa gaiezza e fin nei più reconditi interspazi dei peli della sua barba. Con garbo sorrideva all’offerente e tendeva veloce la mano verso il cilindrato di tabacco.
Chi era dunque costui? un folle, un nichilista, un filosofo, o semplicemente un mendicante che godeva delle sue stranezze? Sulle origini dell’Uomo Cane sono girate per Mazara le più fantasiose, le più incredibili ipotesi circa le motivazioni che avevano condotto un essere umano che certamente era stato in passato, alle attuali condizioni di semplice parassita della società. Tutti coloro che ebbero a scambiare qualche parola con il misterioso individui trassero la conclusione che egli fosse un soggetto fornito di cultura e la sicurezza che il luogo di nascita di quell’uomo potesse essere individuato on un punto del Nord Italia.
Tra le molte storie che circolavano sul suo conto una era senz’altro fantastica ed incredibile.
In giro si raccontava che un tempo l’Uomo Cane fosse stato un irrequieto giovane appartenente ad una nobile e ricca famiglia. Educato alla fede cristiana, egli presto se ne allontanò, divenendo un sarcastico materialista, disposto ad ogni momento a volere dimostrare come Dio non fosse stato altro che un parto della debolezza umana nel suo eterno rifiuto della morte. Terminati gli studi, il giovane prese a viaggiare frequentemente e per periodi di tempo sempre più lunghi. A nulla valsero i tentativi dei familiari di farlo sposare a qualche fanciulla di buona famiglia. Alle catene del matrimonio egli preferiva gli incontri brevi e fugaci con le mogli di altri, i bordelli, una vocazione questa che gli procurò seri guai con qualche maschio geloso e sospettoso. Prese a frequentare le taverne e i luoghi frequentati da gente il cui sistema di vivere era ai margini della legge e nel divenne presto l’instancabile animatore.
Pe i più che lo ebbero a frequentare in quei giorni, il trascorrere della sua giovinezza fu un continuo degradarsi ad un sistema di vita sociale fatto di violenza e di negazione di ogni valore positivo, di qualsiasi regola o norma che guida una comunità. Per altri, molto pochi in verità, il suo condursi quotidiano fra la gente era invece una sfida alle meschinità ed a tutti i formalismi che tenevano freddamente uniti gli individui più disparati e che lui decisamente rifiutava.
Il momento cruciale dell’esistenza di questo giovane ribelle venne presto e senza che egli stesso potesse in qualche modo prevederne gli sviluppi successivi. Erano quelli gli avventurosi anni della rinascita industriale, in Italia l’intera popolazione era pervasa da un grande fervore costruttivo e gli affari andavano a gonfie vele, ovunque operai ed artigiani si affaccendavano attorno alle macchine utensili producendo ricchezza che facilmente veniva venduta sui mercati del mondo. L’italiano cominciava a viaggiare, nasceva il turismo di massa organizzato. Colui che doveva divenire l’Uomo Cane, rifiutava ancora tutto questo modernismo forzato. Individualista, oltre che agiato economicamente, egli aveva acquistato una barca e con essa di tanto in tanto compiva lunghe escursioni per il Mediteraneo. Durante uno di questi viaggi egli venne a trovarsi nel Canale di Sicilia nel bel mezzo di una tempesta. Il vento soffiava fortissimo, alte ondate presero ad abbattersi sulla piccala imbarcazione minacciandola pericolosamente. Il natante prese a scricchiolare e a gemere impietosamente mentre la tempesta aumentava d’intensità. Un colpo di vento più forte degli altri fece saltare il timone e con gran fracasso scomparve fra le onde. La barca divenne ingovernabile rendendo inutili gli sforzi dell’uomo che la guidava.
Improvvisamente il marinaio si sentì perduto, ebbe paura della sua fine ormai prossima e come in un film vide in pochi istanti tutti i momenti principali della sua breve esistenza, rendendosi conto dei molti errori compiuti e prima che la barca venisse travolta definitivamente dalla furia degli elementi, pentito, chiese perdono a Dio di tutti i suoi peccati, prima che la realtà attorno a lui scomparisse in un grigio oblio.
Quanto tempo trascorse prima che lo sfortunato giovane riprendesse conoscenza, , un’ora, un giorno? chissà! Allorchè il naufrago riprese il contatto con le cose che lo circondavano, certo era passato molto tempo, non era più in alto mare. Si trovava steso carponi sulla sabbia di una spiaggia deserta, le onde ormai placide gli lambivano dolcemente i piedi nudi, le vesti inzuppate fradice di acqua, erano strappate in più punti.
Alzatosi in piedi si accorse che a poca distanza da lui si trovava un centro abitato, tese l’orecchio in quella direzione ed ebbe la sensazione di udire il rumoroso brusio della gente che l’abitava, ma più fortemente rimase scosso da un suono che identificò per quello della campana di una chiesa che il quel momento chiamava i fedeli a raccolta. E si ricordò di colpo gli ultimi drammatici momenti vissuti sulla barca e preso da forte commozione si inginocchiò sulla sabbia e si mise a pregare. Prima con difficoltà, poi con sempre maggiore sicurezza le parole uscivano dalla sua bocca per tanto tempo serrata, il volto bagnato per le molte lacrime che gli uscivano dagli occhi.
– “Signore, singhiozzò, ho vissuto una vita sacrilega e piena di ogni peccato, meritavo non una, ma mille volte di morire eppure la tua misericordia ha voluto che io vivessi ancora per ravvedermi delle mie colpe”.
SI fece il segno della croce e pregò ancora a lungo per la salvezza della sua anima. Qualche ora più tardi l’uomo aveva già deciso per la sua vita futura. Era stato ricco, adesso sarebbe vissuto come il più povero degli uomini, era stato superbo, sarebbe vissuto come il più umile degli uomini.
Si avviò deciso verso Mazara vicino alla quale la sorte lo aveva fatto naufragare. Da quel giorno gli abitanti di quel centro marinaro ebbero a registrare la presenza dello strano individuo fra le vie cittadine, incuriosendosi ogni giorno di più per il comportamento poco usuale che il mendicante teneva. Qualcuno scherzando prese a chiamarlo Uomo Cane e da quel giorno egli fu l’Uomo Cane. La sua dimora prese ad essere la zona attorno alla Cattedrale, il suo sostentamento la carità dei mazaresi.
Qualche tempo dopo il miracoloso salvataggio, l’Uomo Cane ne diede notizia alla propria famiglia. Alla lettera accluse anche la dichiarazione personale con la quale rinunciava a tutti i suoi beni in favore dei parenti più stretti. Ricevuta la lettera costoro ebbero buon cuore a spedire al congiunto una discreta somma di denaro che questi rimandò indietro. Ormai aveva tutto ciò che gli serviva, ed il come ottenerlo un continuo ricordargli la volontà divina.
I parenti dell’Uomo Cane non rassegnandosi all’idea che un loro congiunto potesse andare in giro per le strade a chiedere l’elemosina, chiesero ed ottennero l’intervento delle locali autorità, essi stessi intervennero personalmente venendo a Mazara, maturo fu inutile. Con educazione, ma fermamente l’Uomo Cane spiegò i motivi della sua scelta, ed agli interessati non rimase che prenderne atto.
Visse in quelle condizioni per moltissimi anni. Alla sua morte i mazaresi commossi per quella vita condotta in dignitosa miseria, parteciparono numerosissimi al suo funerale, dimostrando ancora una volta agli occhi del mondo che anche un misero può mantenere una dignità di affetto e di rispetto.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 Carlo era uno dei tanti ragazzi che arrivavano a Mazara negli anni sessanta per venire a frequentare l’Istituto Tecnico Industriale “Ruggiero D’Altavilla”. Grazie alla ricchezza che le veniva dal mare questa cittadina godeva già in quel tempo di un grande benessere che portò la gente del luogo ad una sorta di consumismo aberrante, che tendeva a dilapidare la ricchezza accumulata, con ampie fatiche e nel più breve tempo, nelle cose più futili, come ad esempio un gioiello costoso, una bella macchina.
Carlo era uno dei tanti ragazzi che arrivavano a Mazara negli anni sessanta per venire a frequentare l’Istituto Tecnico Industriale “Ruggiero D’Altavilla”. Grazie alla ricchezza che le veniva dal mare questa cittadina godeva già in quel tempo di un grande benessere che portò la gente del luogo ad una sorta di consumismo aberrante, che tendeva a dilapidare la ricchezza accumulata, con ampie fatiche e nel più breve tempo, nelle cose più futili, come ad esempio un gioiello costoso, una bella macchina.
Un ambiente sciupone e godereccio, che il povero Carlo si trovò a dover subire più che a vivere per libera scelta. Conobbe le gesta eclatanti dei personaggi più famosi della comunità e ne era affascinato. Durante la notte, mentre il Mazzaro scorreva placido sotto la sua finestra, si chiedeva se per caso tutte quelle storie che sentiva raccontare in giro, non fossero frutto di fantasie popolari. A volte si domandava con rabbia se era giusto che poche persone potevano starsene alla finestra a buttare i propri soldi, mentre la gente come lui rimaneva in tremula attesa aspettando di potere arraffare il superfluo che gli altri buttavano . Quasi sempre concludeva le sue riflessioni, quando le palpebre cominciavano a chiudersi, mugugnando che la vita era una gran porcata, ma lui avrebbe fatto del suo meglio per afferrare l’occasione buona se questa si fosse presentata.
Sin dal suo arrivo a Mazara del Vallo, Carlo si sentì irrimediabilmente escluso dalla movimentata vita sociale di quella comunità. La gioventù locale godereccia e molto alla mano, da tempo aveva rotto la differenza fra le varie classi sociali, unico grave pregiudizio che rimaneva foertemente abbracciato fra gli eredi del principe di Ibn Mankund; quello del matrimonio fra pari. Una ragazza infatti veniva lasciata libera di andarsene a letto con chi più gli piaceva, ma al momento del matrimonio; che questo sacramento venisse contratto fra i pari grado per favore!
Viveva dunque quella gioventù in una frenetica libertà, amava mettersi in mostra ogni pomeriggio accalcandosi nella tortuosa Via Garibaldi, gotha e vetrina d’esposizione di ogni sentimento del popolo mazarese, sfavillante di luci multicolori, momento sacrale per un primo approccio, esposizione permanente del proprio benessere per i nuovi arricchiti.
Il giovane provinciale aveva sempre rinviato l’incontro con la comunità, per questo diventava sempre più irascibile e scontroso con i propri amici che presto cominciarono a bisbigliare malignamente alle sue spalle. Qualcuna di queste maldicenze arrivò pure alle sue orecchie e Carlo s’infuriò con il principale responsabile. Si rinchiuse sempre più in se stesso, dedicandosi allo studio, ma senza apprezzabili risultati. Era svogliato, con la mente continuamente tormentata dai fantasmi notturni di belle donne. Il quelle condizioni sarebbe stato difficile per chiunque concentrarsi con successo sui problemi di trigonometria.
Crlo intuiva bene come poter risolvere tutti i suoi problemi; trovarsi una ragazza, era questo un problema facilmente risolvibile. Difficoltà invece il giovane ne avrebbe avute parecchie, più in là, al momento di portare la ragazza in discoteca o più semplicemente per entrare nel bar Mokarta per offrirle un gelato. Compiere simili gesti, si dirà non richiede molta energia, ma occorre certamente qualche spicciolo che lui non aveva in tasca, ne tanto facilmente avrebbe potuto procurarseli.
La famiglia del giovane, infatti per mantenerlo agli studi compiva grandissimi sacrifici, ed i soldi erano davvero pochi. Si poteva dire che se Carlo a pranzo consumava qualcosa in più del previsto ciò sarebbe stato sufficiente a fargli saltare la cena.
Da qualche giorno Carlo era più depresso del solito, di fronte alla sua stanza, da un balcone di un vecchio edificio ogni tanto si affacciava una bella ragazza dai capelli scuri, gli occhi dello stesso colore, si chiamava Antonella e i due ragazzi avevano preso a scambiarsi occhiate sempre più lunghe, sempre più cariche di sentimenti. lei mostrava di gradire, oltre ogni dire, le attenzioni del giovane e sembrava che ogni parte della sua femminilità appena sbocciata o acerba ne risultasse appagata. Una disponibilità che provocava nel giovinetto sentimenti e passioni contrastanti, la propria vanità mascolina veniva ad essere appagata, ma nel contempo cresceva la disperazione al pensiero che prima o poi doveva decidersi a chiederle un appuntamento. Quei maledetti soldi continuavano a balzargli malignamente alla mente rovinandogli quei pochi momenti di felicità che quella passione gli portava.
Eppure Carlo era ormai deciso a chiederlo questo appuntamento e molto presto anche se non voleva correre il rischio di perdere la ragazza che stufa di aspettare una sua iniziativa si sarebbe rivolta altrove. Carlo per la verità un tentativo per rimediare i soldi lo aveva fatto, quando telefonando alla madre gli aveva chiesto qualche soldo in più per quel mese per un non meglio imprecisato libro che doveva acquistare, la donna al telefono gli aveva chiesto di pazientare qualche giorno ancora, il padre doveva vendere un po’ di grano e se l’acquirente pagava come si diceva “alla mano”, lei avrebbe provveduto subito ad esaudire quella richiesta.
Ancora una volta dunque il poveraccio doveva aspettare qualche tempo ed Antonella ormai cominciava a dare segni d’impazienza. Se ne era reso conto il povero innamorato il giorno in cui lui osservando di nascosto i movimenti della ragazza, gli era sembrato che la ragazza guardasse in un’altra direzione, semplice coincidenza? chissà. Sapeva che la pazienza di una ragazzina è molto limitata e che altri al suo posto avrebbero avuto meno scrupoli e meno fissazioni, ma lui era fatto così e per quanto cercasse di cambiare non riusciva ad andare contro se stesso.
Quella mattina recandosi a scuola Carlo stava pensando, ai suoi guai, aveva lasciato la casa dove stava a pensione presso una gentilissima vedova, per strada fantasticava sui mille modi per risolvere i propri guai che gli sembravano davvero troppo grandi per lui, ma era arrivato a scuola senza avere trovato una soluzione realistica.
L’Istituto Tecnico era situato in una antica costruzione di fronte alla vecchia pescheria dall’altra parte del fiume, per arrivarci i più mattinieri prendevano la strada del ponte, situato molto più a Nord della scuola, gli altri, attraversavano il largo braccio d’acqua con una vecchia chiatta.
Carlo anche quella mattina era arrivato con qualche minuto di anticipo dal suono della campana, decide l’ per l’ di avviarsi all’ufficio postale che aveva la sede nei pressi dell’Istituto per cambiare una banconota da L. 10.000 che portava gelosamente custodite nelle tasche dei pantaloni . Doveva pagare ancora l’affitto mensile della stanza e la signora Luisa, la sua padrona di casa, da qualche giorno anche se non glielo aveva chiesto espressamente, mostrava che non avrebbe aspettato ancora per lungo tempo.
Entrando nell’Ufficio Postale chiese all’impiegata alcuni francobolli. Davanti a lui c’era un anziano alquanto sordo e l’impiegata urlava e gesticolava per far comprendere al vecchietto qualcosa a proposito della sua pensione che non era arrivata puntuale. Carlo osservò distrattamente la donna dietro al banco, doveva essere di bassa statura, anche se arrampicata sullo sgabello com’era, riusciva a porsi al di sopra degli astanti qualche centimetro, ma sufficiente per farla emergere sulla calca delle persone che si trovavano dentro l’Ufficio durante le ore di punta.
Portava un paio d’occhiali così spessi che a qualche cliente davano la sensazione che fossero due fondi di bottiglia colorati. Finalmente convinto dalle spiegazioni dell’impiegata, il pensionato si fece da parte.
Carlo chiese due francobolli per cartolina ed uno per lettera. Lei, la donna degli spessi occhiali, lo servì subito ed il giovane poggio sul pianale del banco una banconota da diecimila lire, tutta spiegazzata, che le giovani mani tentavano inutilmente di stirare. La donna le prese con un certo disgusto dipinto sulle labbra, le sollevò lentamente contro la luce per controllarne l’autenticità, ed assicurata in tal senso le fece sparire in un cassetto che subito andò a coprire tra le pieghe del grasso ventre. Carlo tirò fuori un profondo respiro di sollievo, per un attimo aveva avuto il dubbio che le sue diecimila lire, per un sortilegio maligno, fossero risultate false al controllo dell’ufficiale postale. La donna contò il resto della banconota, poi aggiunse altre quattro banconote da dieci. In un primo momento Carlo non fece caso ai soldi del resto che contava mentalmente, mentre essi venivano a toccare il piano di legno.
Prendendoli in mano, egli però fu pervaso da un fremito nervoso, pensò rapidamente che forse l’impiegata aveva commesso uno sbaglio, ma poi come a coprire questo pensiero, si disse, dubbioso, che probabilmente lui aveva dato una banconota da cinquantamila scambiandola per una da diecimila. E visto che l’impiegata si era posta in attesa del prossimo cliente, infilò il denaro in tasca e con una certa premura lasciò l’edificio. Per strada il giovane esaminò il denaro, lo ricontò ripassando mentalmente la propria sia pur esigua disponibilità finanziaria frutto dell’ultima spedizione di denaro da parte della sua famiglia. Finì per concludere che egli non aveva posseduto tanto danaro, dunque l’impiegata quella mattina si era confusa, un errore che al ragazzo aveva sfruttato un bel pacchetto di banconote.
– “Soldi piovuti dal cielo” pensò il giovanotto, nel tempo che attraversò il cancello d’ingresso dell’Istituto e si diede a fantasticare sulle diverse cose che poteva acquistare con tutto quel denaro. Mentre l’insegnante della prima ora avviava stancamente l’interesse della scolaresca parlando di molecole e di atomi, Carlo immaginò lui e Antonella, mentre strettamente abbracciati, varcavano la soglia della tanto sospirata discoteca. Ebbe visione d’immergersi in un lungo tunnel, soffuso di luci di mille colori mentre si alzava il ritmo sfrenato di una canzone inglese, ballò lungamente con la ragazza strettamente abbracciata ed incurante di tutto quanto sei muoveva accanto a lui. Alla seconda ora, Carlo ebbe per un attimo il dubbio che ciò che gli era accaduto in mattinata nell’ufficio postale non fosse altro che uno stupido sogno, la sensazione della mano sul mazzetto delle banconote fugò ogni perplessità in lui, un gesto che ripetè ogni qualvolta l’incertezza tornava ad assillarlo. Alla terza ora chiese ed ottenne di potere uscire. Dentro al bagno, con la pota ben chiusa tirò fuori il denaro 3 lo ricontò un paio di volte. Nel riporre il denaro in tasca per la prima volta si sentì impacciato, come se questo fosse diventato improvvisamente risposo ed ingombrante. Stranamente gli venne da pensare che in fondo quel denaro gli era stato dato per sbaglio, subito però nel suo cervello s’aprì un’altra finestrella e pensò confortato a tutte le volte che recatosi in un negozio egli fosse legalmente derubato dal commerciante.
– “Bene” pensò soddisfatto – “questa volta è toccato a me dover incassare qualcosa”, e gli venne da pensare come al mondo vi sia una specie di legge di compensazione che regola i rapporti monetari fra i singoli individui.
Per sera la sicurezza del giovane era stata nuovamente messa min crisi. Durante il pomeriggio aveva tentato di comprare un piccolo regalo per la ragazza, ma già davanti al negozio era stato colto dal timore che qualcuno potesse chiedergli la provenienza di quel denaro, un’idea tanto assurda che finì per divertirlo. Rincasò sul tardi senza ancora avere speso una sola lira. Il rimorso per avere approfittato della disattenzione di una povera donna cominciava a scavare profonde gallerie nel suo animo e non lo lasciava più tranquillo un solo momento. La notte successiva andò ancora peggio. Il sonno non voleva scendere e si trascinò nella dormiveglia fino alle prime luci dell’alba in uno stato d’agitazione crescente. Ad un certo punto fu persino preso dalla paura che scoperto l’ammanco, i carabinieri potessero venire lì durante la notte per arrestarlo. Impaurito per quest’ultima ipotesi, Carlo decise che l’indomani, egli stesso si sarebbe recato di buon’ora presso l’ufficio postale per riconsegnare all’impiegata il denaro incassato ingiustamente. Albeggiava ormai, si alzò ed uscito di casa si avviò verso l’ufficio postale dove la mattina prima gli era capitata l’incredibile vicenda. Aspettò, l’ seduto per circa due ore l’apertura e ad ogni minuto che passava sentiva espandersi dentro il suo corpo una sensazione benefica di sollievo. Fu proprio l’impiegata dalle lenti spesse che venne per prima ad alzare la saracinesca. Carlo gli raccontò tutto d’un fiato come il giorno prima avesse ricevuto il denaro, scusò il suo ritardo con il pretesto o giustificazione che al termine delle lezioni l’ufficio postale era già chiuso. La donna commossa per quello che credeva un gesto di grande generosità abbracciò il ragazzo che gli stava davanti, ringraziandolo lungamente, poi mossa a grande generosità, mise la mano nel borsellino e ne tirò fuori mille lire che a gran forza mise dentro la tasca dei pantaloni di Carlo, incurante delle proteste di quest’ultimo.
Carlo si avviò verso un vecchio palazzo in direzione opposta alla scuola ove in uno dei tanti balconi spesso si affacciava una fanciulla bruna. L’avrebbe chiamata e forse lei sarebbe venuta giù nell’androne. Li dentro il timido Carlo, protetto dalla frescura del luogo si sarebbe sforzato a bisbigliare ad Antonella qualche frase affannosa, un pò impiastricciata, ma che lei avrebbe compro benissimo, l’amore è anche questo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Era da poco arrivata la primavera e la montagna sembrava essersi vestita a festa, tanto che sui pianori, lungo le pendici era tutto un rifiorire di colorati e profumatissimi fiori. Quel monte duro e crudele sembrava in quei giorni una dolce ragazza che si faceva bella per il proprio amante. Dappertutto molti uccelli di specie diverse, si davano da fare a raccogliere fili d’erba secca che sistemavano, intrecciando con cura, sui rami d’albero dove pazientemente costruivano il proprio nido. Era quello il periodo dei grandi amori e presto sarebbe venuto il momento in cui i pennuti avrebbero depositato le uova da covare, le future mamme erano preoccupate affinché il nido fosse stato pronto al momento giusto.
Una natura incontaminata ed un po’ selvaggia che obbediva ancora alle sue leggi primordiali, dov’era impossibile trovare la minima traccia della civiltà facilona e consumistica.
Soltanto un lontano rombo di un aereo militare che stava in quel momento sorvolando le nubi, ricordava al giovane pastore che in quel mentre si arrampicava lento sulla costa che la grande civiltà dello spreco era molto vicina, quasi ad un tiro di fucile da lì. Si, perché quel giovane garzone era anche lui parte di quel grande quadro naturalistico.
Seguito da un cane color rosso chiaro, egli appoggiandosi ad un nodoso bastone si adoperava per tenere il passo con quello del gregge che davanti a lui si muoveva spostandosi in modo disordinato incontro al vento. Brucando qua e là qualche filo d’erba nascosto dietro un sasso; decapitando a volte qualche corolla candida come la neve. Gli animali si arrampicavano svelti, alzando di tanto in tanto il muso alla brezza per rituffarlo subito in quell’immenso tappeto verde. Qualche agnellino dolce ed aggraziato, un po’ incosciente, si allontanava dal gruppo incurante delle titubanze delle madri che nei giorni scorsi avevano visto cacciare nella zona una vecchia volpe. Forte e ammonitrice s’alzava a volte la voce del vecchio montone come a richiamare i giovani maschi all’osservanza della sua legge e del diritto sul gregge perché continuasse l’armonia della comunità! A volte quel verso forte e poderoso sortiva l’effetto voluto, gli animali che distrattamente si erano allontanati, a quel richiamo imperioso raggiungevano il gregge scomparendo fra esso, qualcuna, sorda al rimprovero maschile, mostrava per esso indifferenza e continuava il pascolo in solitudine, ed allora era il pastorello ad intervenire prontamente. Lanciava all’animale qualche urlo serrato, tirandogli vicino un sasso e presto tutto il gregge continuava a inerpicarsi per il monte. Arrivati sul vasto pianoro, sulla sommità del monte, il gregge si distendeva ed il pastorello un po’ stanco per la strada fatta si concedeva una breve pausa sdraiandosi sull’erba dietro un cumulo di sassi messo lì nella zona a fungere come limite del confine fra i vari prati.
Il vento di aprile tirava sempre in modo fastidioso, a volte forte, dietro quel riparo di fortuna il garzone si sentiva preso da un forte senso di benessere, tirò fuori dalla saccoccia un vecchio fumetto sgualcito e bisunto e sfogliò distratto qualche pagina. Ad un certo momento si rese conto di avere appetito, mise da parte il fumetto ed aprì di nuovo la saccoccia per tirarne fuori un pezzo di pane, non molto fresco, almeno all’apparenza, ed un pezzettino di formaggio. Il giovane tolse la cosata con il coltello e con un gesto deciso la buttò a terra lontano da lui. Il cane che seguiva attentamente tutte le mosse del padrone scattò contemporaneamente al braccio del pastore, riuscì ad afferrare il pane prima che questi toccasse terra. In men che non si dica lo inghiottì in un miscuglio di briciole, di saliva e di terra che sprizzavano dalla bocca semiaperta, l’animale tornò a mettersi in posizione di riposo, gli occhi attenti ad ogni sia pur piccolissimo movimento del suo padrone, nella vana speranza che questi ripetesse l’offerta.
Consumato il povero pasto, il giovane tornò a controllare fugacemente il gregge, poi tornò ad addossarsi ancora di più al riparo. La mente del garzone, liberata per un attimo dal travaglio del suo lavoro prese a scorrazzare impetuosa sulle avventure di un fantastico eroe dei fumetti che a lui piaceva tanto. Terminò in bellezza correggendo un paio di finali di storie del famoso personaggio che a suo dire l’autore aveva scritto senza particolare calore, cadendo in un sonno pesante.
Il garzone si svegliò qualche tempo più tardi sorpreso che fosse trascorso tanto tempo. Notò allarmato che il sole si avvicinava pericolosamente alla linea del tramonto. Preoccupato di arrivare tardi alla masseria per poter mungere le pecore il giovane riunì gli animali in fretta e furia e li avviò lungo il sentiero che conduceva ai recinti. Era ormai buio allorché egli arrivò nei pressi del caseggiato, ad aspettarlo vi era il padrone che evidentemente contrariato per quel ritardo, bestemmiava di brutto con lunghe imprecazioni dirette al suo dipendente che aveva tardato quella sera.
Man mano che gli animali entravano nel recinto, l’uomo li contava attento e veloce perché nessuna di esse scappasse alla sua attenzione. Al termine del controllo il curatolo potè dedurre che dal gregge mancavano la bellezza di dieci pecore. Riprese ad insultare il proprio dipendente, mentre il poveraccio se ne stava in silenziosa mestizia, sempre più confuso ed impaurito. Non contento il vecchio curatolo impose al garzone imprevidente di ritornare sul monte per andare alla ricerca degli animali mancanti, aggiungendo che in caso negativo lo avrebbe lasciato digiuno quella sera: -“La tua minestra andrà a scaldare la pancia dei cani, loro almeno durante la notte abbaiano e fanno il loro dovere”.
Amareggiato, con gli occhi pieni di lacrime il giovane garzone si avviò lentamente sugli stretti sentieri della montagna. Era avvilito per tutti quei rimproveri, anche se stavolta, ammetteva in cuor suo, che erano giustificati. Il suo padrone era davvero una brutta bestia, lo maltrattava spesso, e dire che in compenso del suo lavoro egli versava alla famiglia una vera miseria, qualche tumulo di frumento e qualche lira al mese. Eppure per lui era giocoforza stringere i denti e sopportare i rimproveri giusti o sbagliati che fossero.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Un vento freddo di tramontana aveva fischiato per tutta la notte fra le stradine del paese, trasportando nuvoloni neri, carichi di pioggia. L’acqua era caduta in abbondanza sopra le vecchie case, infiltrandosi fra le crepe e le tegole che l’infuriare del temporale aveva stravolto. Più di un abitante quella notte fu svegliato dall’infuriare dell’acquazzone e dalle copiose infiltrazioni.
Comparvero “uteri” un po’ dappertutto, sui tetti, sulle cassepanche, e fatto ancora grave, entro i “canizza” pieni di grano. Fortuna per Carmelo che lui non aveva mai avuto il piacere di conservare un po’ di frumento in casa propria e poi quella notte, chi mai avrebbe potto dormire.
L’indomani di buon’ora infatti Carmelo e la moglie sarebbero saliti sopra la corriera che li avrebbe condotti a Palermo da dove avrebbero preso un treno che li avrebbe portati in uno sconosciuto paese della Germania.
La sera presto terminato il via vai dei parenti ed amici che venivano a prendere commiato dai congiunti, la coppia si era data da fare per preparare le valigie ed era davvero un miracolo assistere a tale spettacolo, vedere come una vera montagna di formaggi, di farina, indumenti, ecc. ecc., potesse sparire dentro un paio di misere valigie. Un lavoro di gruppo che la coppia condusse in modo davvero eccellente, con la donna a sistemare minuziosamente ogni cosa e con l’uomo che schiacciava il tutto entro le valigie sedendosi pesantemente sopra esse. Alcune passate di spago vennero poi a sigillare lo sforzo congiunto dei due.
Rimosse le valigie e poste vicino alla porta d’ingresso i due erano andati a letto e subito lui si era reso conto che quella notte sarebbe stata difficile da trascorrere elettrizzata com’era dall’imminente viaggio; lei si era rifiutata di fare l’amore. L’uomo contrariato, si era ritirato schermendosi dietro comode scusanti, ma sicuramente deluso tentò di dormire senza peraltro riuscirci. Nel proseguo della notte, il nubifragio provocò guasti anche al tetto della sua casa e l’acqua infiltrandosi attraverso le tegole, aveva costretto la coppia a scappare dal letto per rifugiarsi in un angolo asciutto, dove rimasero a lungo coperti da qualche coperta alla meglio. Fu una notte lunga per il nostro Carmelo che provvide a volte ad accorciarla tirando (tante) bestemmie all’indirizzo di tutti i santi colpevoli a suo dire del temporale notturno.
– “…porcu di san giuseppi, doppu sta min… di nuttata, di stu caz… di paisi mi nni vaju cuntentu. Cuncittina…, tu zittuti ca sinnò but…di chiddu diu va a finiri ca m’arrabbio pi vero”.
La corriera arrivò strombazzando furiosamente in paese, non c’era molta gente che partiva con un tempaccio simile, eppure anche quella mattina vi furono i soliti litigi per accaparrarsi i posti migliori, inutilmente rabboniti dall’autista che tentava di farli ragionare. La vecchia corriera si avviò per la strada in direzione della città fra furtivi segni di croce, singhiozzi repressi e furiosi conati di vomito che le prime buche affrontate dalle ruote sulla carrozzabile, avevano suscitato in molti dei viaggiatori, mentre l’autista, al pensiero del lavoro di pulizia straordinaria che avrebbe dovuto eseguire più tardi, prese ad imprecare all’indirizzo dei malcapitati, intanto l’uomo schiacciava selvaggiamente il piede sull’acceleratore ed un paio di quegli indisposti viaggiatori finirono per sputare l’anima, eppure se ne stettero in un canto, silenziosi, timorosi che un loro lamento potesse irritare ancora di più l’autista.
Carmelo e Copncetta se ne stavano in quarta fila, stranamente silenziosi, spalla contro spalla per farsi coraggio, di tanto in tanto si guardavano negli occhi, poi tornavano a fissare la campagna al di là del vetro, quella loro arida terra che ai primi chiarori dell’alba andava delineandosi alla vista. Ma il sonno perduto, le emozioni vinsero pretto Carmelo che finì per reclinare il capo sul seno della moglie addormentandosi pesantemente. Si risvegliò quando il mezzo di trasporto transitava per la periferia della città, semi sommerso di borse e di fagotti che i viaggiatori saliti alle fermate intermedie avevano sistemato un pò ovunque senza complimenti di sorta.
Carmelo, memore delle storie di furti di valigie di cui aveva sentito parlare nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo, non appena il mezzo di trasporto rallentò, si mosse celermente attraverso il corridoio nell’intento di avvicinarsi il più possibile all’uscita, ma altri viaggiatori avevano avuto la stessa idea ed il risultato fu un improvviso quanto selvaggio intasamento di gambe che cercavano invano di scrollarsi di dosso altre gambe o fastidiosi bagagli, il tutto nello spazio di un paio di metri. Qualche donna, prese a gridare e la confusione aumentò non appena fermata la corriera, davanti all’uscita si presentarono un gruppo di vocianti facchini che reclamavano ad alta voce le loro personali prestazioni professionali, nella comprensibile speranza di accaparrarsi qualche cliente; un tirare i bagagli dei viaggiatori in varie direzioni e spesso senza il volere dei proprietari.
Concetta ed il marito appena scesi a terra fecero muro con i propri corpi in difesa del proprio bagaglio finché scemata la ressa dei facchini distolti dall’arrivo di altre corriere, si mossero verso l’interno della stazione.
Concetta fu lasciata dal marito a guardia delle valigie (per maggior sicurezza lei sedette graziosamente sopra di esse), mentre un sempre più nervoso Carmelo chiedeva a più riprese, assicurazioni sul binario del treno in partenza per Milano. Più tardi mentre il treno entrava lentamente in stazione, egli speranzoso di accaparrarsi un paio di posti a sedere, pensò bene di dare l’assalto al treno ancora in movimento. Si lanciò verso uno sportello, scansando abilmente un po’ di calci che gli tirava un seccatissimo portabagagli inspiegabilmente padrone del treno assieme ad altri suoi colleghi, riuscì alla fine ad infilarsi entro uno dei scompartimenti dove provvide ad occupare i posti mettendovi sopra tutto quanto di personale egli portava addosso.
Affacciatosi al finestrino prese a chiamare la moglie e costei alfine notata la figura familiare si mise a spingere con grande sforzo tutto il bagaglio, non avendo cuore a lasciare indietro qualcosa anche se momentaneamente. Buon per la donna che un paio di soldatini in vena di gentilezze si offrirono di aiutarla e di tanta generosità essi si pentirono subito dopo, non appena si resero conto che quelle valigie sembravano pezzi di piombo tanto erano pesanti
Per i due coniugi, il viaggio fu un tuffo meraviglioso nella geografia italiana che servì anche a colmare la loro ignoranza in materia, visto che piccolissimi erano stati invitati dai propri genitori ad abbandonare la scuola per andare “a scuttari u pani’ ‘ , anche se per la verità essi avevano continuato a conoscere quella geografia che gli emigranti tornati per le feste in paese raccontavano loro: “A Missina c’eni lu strittu; un pezzu di mari che si passa cu lu ferrabbottu, poi s’arriva ‘n’Calabria, terra muntagnusa e china d’arvuli. Duranti la notti si passa pi Napuli; guardativi chi vi futtinu li portafogli e poi la Toscana e subitu appressu incuntrati gallirii senza fini pi spuntari nda li chianuri a tuttii tempi virdi, pi arrivari infini a Milanu, bedda granni, chi ti ci perdi spissu e dunni l’aria puzza di carvuni e di mmerda puzzulenti”.
Concetta passò tutto il tempo del viaggio con gli occhi incollati al finestrino, richiamando di tanto in tanto il marito se il paesaggio si offriva alla vista in modo particolarmente bello. Spesso lui resisteva alla curiosità che a suo dire lo rendeva ridicolo di fronte ai suoi occasionali compagni di viaggio e tuttavia essi non lo avrebbero manifestato, colpiti com’erano dalla vivacità dello sguardo di quell’uomo che esprimeva arguzia ed intelligenza. Fecero tappa a Milano, mezza giornata di tempo libero in attesa di salire sul treno che li avrebbe condotti in Germania, verso quel tanto sospirato lavoro, mercé l’intervento di un loro lontano parente emigrato sul posto già da qualche anno. Per inciso tale “favore”, al povero Carmelo sarebbe costato piuttosto salato: una collana d’oro per la moglie del disinteressato compare, ed ancora due fazzoletti di terra alberati erano stati chiesti in affitto dal campiere .
L’uomo osservava attentamente pure le molte donne che transitavano per i treni, lo urtavano a volte, passandogli vicino senza provare turbamento alcuno.
“Bedda Matri, quantu pilu chi c’è, quantu pilu, e chistu eni ancora nenti, l’amici chi pi Natali vinniru in vacanza dicianu chi li fimmini tedeschi sunnu ancora cchiù cavudi. Così di nun ci cridiri, li fimmini ddà vannu a cercarisi li masculi quannu ci piacinu .
Una volta sul treno i due sposi si accorsero quasi subito che quello dove erano appena saliti, era un treno diverso, e questo sicuramente non per i cartellini d’avvertimento che alla coppia erano ugualmente incomprensibili sia che fossero scritti in italiano sia che la scrittura fosse in lingua straniera, ma era a loro ostile per una sorta di religioso raccoglimento che si poteva percepire fin nei più piccoli angoli nascosti delle vetture. Non si udivano clamori fastidiosi e gli emigranti che ivi viaggiavano si rannicchiavano spauriti nei propri posti. Adesso che erano fuori dal proprio paese, più forte si faceva sentire l’incognita sul futuro. Anche quel gruppo di turisti germanici che rientrava dalle vacanze e che fin dalla partenza del treno canticchiavano qualcosa di osceno bevendo del vino acquistato in stazione, adesso sembrava voler cambiare atteggiamento. La breve fermata ai confini, un breve controllo di alcuni funzionari metodici e pur così incisivi, privi di quei fronzoli appiccicosi tipici dei loro colleghi italiani, ebbe il potere di scuotere gli emigranti sul treno e tutti si erano raddrizzati, pronti ad obbedire celermente agli ordini impartiti. Nei loro paesi d’origine avevano finora regolato la loro vita sul movimento del sole al sorgere dell’astro luminoso iniziavano la loro fatica quotidiana nei campi per terminare al tramonto quando caricati gli attrezzi sulle proprie spalle ritornavano stanchi ed affamati alle umili case attraverso viottoli stretti e trazzere. Molti di loro aspettavano un giorno di pioggia per rimanere a letto a poltrire mentre una bella giornata di sole serviva all’intera famiglia per spostarsi in campagna per il lavoro che diventava in quel caso una saporosa scampagnata. Certo anche a questo pensavano quei poveri emigranti, uomini privi di qualsiasi istruzione, destinati loro malgrado a divenire carpentieri ed operai, presto ammirati per l’acquisita abilità eppure disprezzati perché tutto sommato essi rimanevano stranieri. Quando la loro opera al fine risultò superflua essi furono rimandati indietro senza troppi complimenti, senza un seppur timido ringraziamento, dimenticati.
Carmelo guardava di sottocchio la propria donna, alla luce di quelle rivelazioni muliebri, non poteva esimersi dal fare confronti con la propria, non che lei fosse brutta, anzi al suo paese passava per una donna piacevole, ma era pur sempre una donna mediterranea ed al pari di molte altre sue coetanee, lei poco conosceva l’arte del trucco capace di migliorare notevolmente l’estetica personale. Concetta aveva una fastidiosissima peluria che le copriva parte del corpo, era inoltre di bassa statura per cui tendeva ad ingrassare naturalmente. Tutto ciò costringeva il povero Carmelo al momento della sua massima eccitabilità a lanciarsi di furia sulla moglie, soddisfatto il proprio desiderio di esso, l’uomo si rigirava lestamente su se stesso e si addormentava. Per Carmelo l’impatto con le milanesi fu traumatico, al pensiero di quelle cosce lunghe due metri egli si sentiva mancare il respiro, così belle e disponibili, tutto ciò era quanto la moglie non avrebbe potuto dargli.
“Fimmini di lettu sunnu. .. fimmini di lettu! l ” continuava a ripetere a se stesso.
Arrivati ad Amburgo, appena scesi dal treno, Carmelo, la moglie ed altri emigrati, furono presi in consegna da un funzionario dell’impresa edile per cui il gruppo doveva lavorare. Sistemati alla meglio sopra un pulmino, furono avviati immediatamente verso l’interno. Percossero appena una quarantina di chilometri, attorno agli sparuti emigranti si presentò un orrendo spettacolo, un fantasmagorico cantiere edile viveva per realizzare una città, ovunque costruzioni iniziavano la loro scalata verso il cielo in un impossibile sfida fra di loro per arrivare prima, strade appena tracciate coperte di fango sopra cui le ruote degli autocarri tracciavano solchi profondi che i successivi ricolmavano aprendole di nuovi. E poi mucchi di terra, vere e proprie collinette, un po’ ovunque ostruivano la vista impedendole di spaziare per la zona.
Il gruppo fu accompagnato presso un baraccamento, ove già molti altri operai edili avevano trovato una sistemazione. Erano gli alloggi che l’impresa edile aveva messo a disposizione dei propri dipendenti e che si faceva pagare trattenendosi robuste quote dalle buste paga settimanali. Ad ogni famiglia spettò uno stanzone con annesso un cucinino, mentre i servizi igienici erano in comune. Il lavoro si presentò più duro di quanto Carmelo avesse supposto, il freddo ed il gelo, poi avevano aumentato le difficoltà ma lui resisteva tenacemente, eroicamente alle difficoltà giornaliere con la forza tipica della sua gente, consapevole che la perdita di quel posto per lui voleva significare la miseria. Con le prime rimesse inviate al paese, egli aveva finito per strabiliare i suoi parenti cominciavano a commentare quel conto corrente che si andava sempre più ingrossando e che ad ogni mese si ingrossava di nuove risorse. Adesso pure Concetta aveva trovato lavoro nella vicina città. Ogni mattina prendeva un mezzo pubblico che ormai arrivava puntuale vicino la baraccopoli, ritornava la sera tardi stanca oltre ogni dire, trascinandosi appresso una pesantissima borsa stracolma di generi alimentari perché la coppia potesse risparmiare sullo strozzinaggio dello spaccio locale gestito dalla ditta edile. Di tale mancanza un dirigente della società si lamento un giorno con Carmelo:
“Cammelo, yah, tu volere fare furbo con noi? Con cranti sacrifici nostra società avere organizzato spaccio, yah? E atesso tu non comprare manciare da noi…”
Carmelo faceva il finto tonfo, “Veru je’, la società fici forti sacrifici pi g’apriri stu spacciu. ju propriu pi chissu nun ci compru cchiù nenti, pi nun ci dari ancora pinseri. ..”. Ed il capo se ne ritornava nel suo caldo ufficio con le pive nel sacco. D’altra parte anche molti altri lavoratori delle baracche si erano fatti furbi, recandosi sempre più spesso in città per fare incetta di scatolami, birra, ecc. ecc., e poi altri negozi cominciavano a sorgere nella zona man mano che le palazzine andavano completandosi ; la città andava affermandosi anche con questi simboli.
Carmelo adesso lavorava come operaio specializzato presso una fabbrica metalmeccanica; addetto alle grandi presse. Un lavoro specializzato che lui si era guadagnato passando attraverso una lunga serie di lavori all’interno della fabbrica dove inizialmente era stato assunto come semplice scopino percorrendo via, via grazie al suo zelo, alle sue capacità istintive, una carriera che tutto sommato soddisfaceva il nostro uomo. Carmelo se ne stava piazzato faccia a faccia con una enorme pressa, un modello molto recente che era l’ultimo ritrovato della tecnica e che aveva mandato in pensione anticipata le vecchie e tristemente nota come: “mangiadita”’, chiamate così nell’ambiente perché fonte di incidenti gravi agli arti prensili. La nuova macchina possedeva un congegno salva-uomo costituito da alcune fotoelettriche che facevano scattare il maglio al momento in cui l’operatore ritraeva le mani scostandosi dalla zona di pericolo. Un’ottima soluzione, e tuttavia Carmelo non tratteneva la sua irritazione per questa soluzione.
“Cu tutti sti novità, ccà va a finiri che sti patruna nun ci lassanu mancu lu tempu pi ghiri a pisciari’ ‘, soleva dire ai suoi amici durante le pause del lavoro. Ed in effetti l’uomo non aveva tutti i torti. La ditta aveva da tempo assunto un ingegnere con il preciso compito di eliminare tutti i tem’pi morti e di razionalizzare al massimo il lavoro nei vari reparti, automatizzarlo ove fosse possibile. Per ogni suo successo, egli oltre ad un lauto stipendio riceveva grossi premi in denaro e percentuali varie sui maggiori introiti della ditta. Si può ben immaginare lo zelo dell’uomo nel fare il proprio lavoro. Dapprima gli operai se la ridevano nel vedere quest’uomo, silenzioso, sempre in giro ad osservare i loro movimenti, in compagnia di un micrometro e di una penna, con un taccuino su cui di tanto in tanto scriveva qualche breve nota. Rimasero perciò amaramente sorpresi allorché sulle direttive dell’ingegnere si presero le prime misure nell’organizzazione del lavoro. Si trattò in quel caso di aumentare il ciclo produttivo nel reparto saldature, ove gli addetti usufruivano di pause piuttosto lunghe fra una lavorazione e la successiva. Questo primo intervento mise sul chi vive l’intero personale, mai come in quella occasione gli operai italiani fraternizzarono con i loro colleghi del luogo. Quell’uomo apparentemente innocuo si stava rivelando molto più pericoloso dei proprietari e di tutti i capireparti messi assieme.
Un tornitore napoletano piuttosto spigliato gli trovò il soprannome adatto: “ncula operai”, e questo divenne il suo nome all’interno della fabbrica. Ancora lui qualche mese più tardi compì il suo capolavoro inserendo alcuni automatismi all’interno del reparto di saldatura riuscendo a far produrre 40 carriole a due operai mentre la stessa produzione in precedenza era prodotta da otto operai. Sei saldatori furono licenziati.
Carmelo ed i suoi amici ormai avevano ben compreso quello che voleva dire applicare il progresso economico alle macchine; una decimazione dei posti di lavoro. Tutti assieme, silenziosamente, dichiararono guerra all’automazione. Il padrone studiava nuovi marchingegni? E l’operaio si difendeva cercando di fregare la macchina, i loro automatismi. Una lotta combattuta da entrambi le parti senza esclusione di colpi. Ad ogni successo di ‘Ncula Operai, la dirigenza per rendere ancora più magnifico il suo successo usava riunire le maestranze e festeggiava l’avvenimento offrendo a tutti birra e dolcini e loro, i poveracci, ingoiavano silenziosamente domandandosi a chi sarebbe toccato la prossima volta, chi di loro non avrebbe rivisto l’indomani la fabbrica perché licenziato. Addentavano i wurstel ben intrisi di senape perché andando giù per lo stomaco bruciasse le amarezze ivi raccolte, mentre le veloci sorsate di birra annegavano un’altra dura sconfitta. Sorseggiando la sua birra Carmelo era tutto preso dalla soluzione del nuovo problema: l’automatismo, che installato sulla macchina scandiva inesorabile l’intervallo fra un pezzo e l’altro, un dannato aggeggio che aveva finito con il rovinare le sue notti di turno passate in fabbrica e d’altra parte non voleva rinunziare alla doppia paga che dal lavoro notturno usufruiva sulla busta paga.
Era l’alba e nei capannoni tutto filava via tranquillo in attesa del cambio ed il ritorno a casa ed ecco all’improvviso, silenzioso ed inaspettato come l’angelo della morte, arrivare sul posto il proprietario. Gli bastò una occhiata in giro per rendersi conto di ciò che i suoi operai intendevano per lavoro notturno. La stragrande maggioranza di essi dormicchiavano stravaccati alla rinfusa su pezzi di cartone o dentro i contenitori di metallo mentre le macchine in movimento muovevano inutilmente i loro utensili in attesa dei pezzi grezzi da rifinire. Furente l’uomo percosse tutti i capannoni, lanciando urla ed imprecazioni all’indirizzo dei propri dipendenti, i quali parecchio preoccupati si rimisero al lavoro.
Per qualche tempo fu uno sciamare di tecnici e di responsabili per ogni dove ad incitare, o a minacciare qualcuno: “Ah.. stronzi italien, voi niente lavorare? Voi volere rovinare me? Io invece sistemare voi tutti e presto’ ‘.
Detto e fatto aveva ordinato agli americani, su consiglio del suo consigliere “’Ncula Operai” centinaia di congegni per l’automatismo delle macchine utensili e per tutti gli operai fu subito notte. Un ago sottilissimo tracciava una linea verticale bastava che l’operaio ritardasse la sua manovra che lo strumento diabolico prendeva a segnare delle linee orizzontali che denunciava ai controllori il lassismo dell’operaio negligente. Occorreva pertanto lavorare con la continuità ed ai tempi stabiliti dai programmatori che per altro non erano mai contenti dei risultati ottenuti dagli operai, a meno che… si, a meno che non si fosse in qualche modo intervenuti per fregare l’automatismo. Dopo alcune notti passate al lavoro Carmelo era ormai sicuro che sarebbe riuscito a fregare la macchina. Ed una notte casualmente scoprì che la sua vecchia giacca poteva far funzionare egregiamente la macchina mentre lui beatamente seduto la agitava davanti al congegno ormai sconfitto. La scoperta prontamente imitata da altri portò alla creazione di un sistema rudimentale manovrato a turno da un operaio mentre gli si impegnavano in lunghe discussioni sul campionato di calcio italiano… la vendetta dell’operaio Carmelo, umile presta opera proveniente dalla lontana Sicilia era così compiuta.
Le donne tedesche… yah,… pitescen… fraulain… Ha quali sensazioni, quante emozioni suscitavano nell’animo del povero Carmelo. Così straordinariamente alte, belle e funzionali, ecco come l’uomo vedeva quelle donne del nord. Il suo sogno era quello di portarsele a letto, magari una diversa dall’altra per ogni notte, ma per un motivo o per l’altro tali desideri erano rimasti semplicemente dei sogni a causa della presenza continua della moglie nella sua vita privata che temendo qualche tradimento da parte del consorte non lasciava spazi vuoti al suo uomo. In attesa che il destino gli portasse una grassa tedesca per farsi passare la voglia, Carmelo si teneva occupato parlandone con gli amici ed usando toni come si conveniva ad un lontanissimo parente dei Valentino. Ogni occasione era buona per parlare di donne. Bastava che egli fosse in ritardo all’entrata in fabbrica: “Cammelo, perché essere in ritardo?”
“Buttana di Diu, zittuti Carl, ti lu dicu in confidenza… assira mi capitau ‘na bedda fraulain tedesca e mi fici tri sciammelle, tantu che stamatina agghiurnau ancora a cavaddu e mi vittu obbligatu a cuminariminni ‘n’autra lesta lesta pi nun dispiaciri dda puvuredda…”.
“Eh, Cammelo, tu volere sempre scherzare, impossibile fare quattro volte amore, vai vai a lavorare che essere in ritardo”.
“Ma chi ffai, nun ci criri? Pezzu di cadduzzuni, portami a tto soru ccà e ti fazzu vidiri jo si eni possibili”.
A volte tentava qualche approccio con qualcuna delle donnone addette alla pulizie in fabbrica, ma quelle sia pur ringalluzzite per l’attenzione che le concedeva quel siciliano, alitando birra da tutti i pori, rifiutavano l’offerta di una notte d’amore indimenticabile, d’altra parte quasi tutte avevano già il loro amante spagnolo o turco che fosse. Infine anche Carmelo ebbe la sua bella occasione, Concetta, sua moglie, a causa di certi disturbi alle ovaie fu costretta a ricoverarsi in ospedale per accertamenti. Ed ecco che Carmelo decise di andare a trovare alcuni suoi compaesani che vivevano in un villaggio vicino. Era ancora intento a scherzare con gli amici sui motivi che avevano portato la moglie a quei guai al sesso che come provocata dal cielo entrò in quella casa una biondona, grassa come lo possono essere quegli animali destinati al macello. La donna chiese ad uno dei presenti se fosse in casa un suo amico, ed avendo avuto risposta negativa si era girata per allontanarsi allorché Carmelo, con un colpo di genio, la invitò a rimanere con loro mettendole in mano un bel bicchiere di birra cosa che lei accettò ben volentieri. Da cosa nasce cosa, al primo bicchiere seguirono altri drinks e poi ancora dei liquori che si alternavano a battute spiritose, spesso untuose ed allusive che facevano letteralmente fondere la donna.
“Vivi, vivi, buttana fitusa, chi a ‘n’autr’anticchia ti fazzu ririri jo’. Vinisti pi Carlu e truvasti a Carmelu e ju privu di Diu lu pilu te le fari stuffari”.
Quando la donna ormai non stava più in piedi, Carmelo con l’aiuto dei presenti, distese la donna sul letto più vicino e dopo aver convinto i presenti ad uscire, la spogliò e tolti a sua volta i propri indumenti vi si adagiò sopra. Stordita dall’alcool, incuriosita più che sorpresa la donna prese a muoversi in modo scomposto, ridendo a più non posso mentre con le sue grasse cosce cercava di stringere Carmelo.
“Ti piaci veru? troia buttana, ma mi fazzu tagliari la testa, si stasira non ti fazzu dire: basta!“.
Ma la donna non aveva proprio voglia di dire basta. Ormai stanco Carmelo rientrò nell’altra stanza ove nel frattempo si erano riuniti eccitatissimi alcuni suoi amici, non ebbe bisogno di dire nulla, a turno i presenti andarono a letto con la donna ormai priva di coscienza seguiti dalle facezie degli altri che ricominciavano a bere.
Intanto fuori un vento freddo e molto forte, portava insistentemente i fiocchi di neve a sbattere contro gli spigoli delle imposte otturando le fessure attraverso cui ogni tanto passava una fastidiosissima corrente gelida, che disturbava i presenti. Un clima di forzata allegria regnava in quella stanza, i fumi dell’alcool e del sesso, sembravano aleggiare, come fantasmi, i volti delle madri, delle mogli, dei figli che aspettavano con impazienza il loro ritorno in quei poveri paesini posti sulla montagna della Sicilia, il ritorno dei propri cari lontani da casa alla ricerca di un po’ di lavoro che li facesse più dignitosi, erano in tanti quella sera eppure ognuno di loro sembrava oppresso da ricordi lontani, solo in mezzo agli altri.
TORNA SU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quella notte Salvo aveva dormito poco e male, passando molte ore in un sonno agitato, pieno di azioni e di pensieri che si accavallavano volti di gente che lui non ricordava di avere mai incontrato, ma non stava male, al contrario. Il perché di quella strana dormiveglia andava collegata con il breve colloquio che il ragazzo aveva avuto con il padre poco prima di andare a letto.
La sera prima infatti, il genitore, che faceva il pastore nei pascoli della Gran Montagna, era arrivato in paese dopo qualche giorno di assenza. Durante la cena, con la famiglia riunita a tavola che ascoltava in religioso silenzio, il capofamiglia andava raccontando alcuni fatti accaduti in quei giorni. Ad un tratto, mentre costui stava terminando l’ultimo episodio capitatogli a proposito di una vecchi volpe troppo invadente con gli agnellini, ecco che Salvo raccolto il coraggio a due mani chiese: “Sai papà, la prossima settimana è vacanza, mi porti con te in campagna?”
La madre si girò verso di lui ed in tono di rimprovero gli disse: “Non devi interrompere tuo padre mentre parla, e poi ti hai già detto che sei ancora piccolo per andare in montagna”.
Salvo divenne rosso, faceva sempre così ogni volta che veniva rimproverato davanti ai suoi fratelli che diamine! In fondo lui era il più grande della nidiata e loro erano sempre lì, pronti a cogliere l’occasione buona per potersi fare qualche risata alle sue spalle.
Il padre al contrario si mostrò interessato per quella richiesta sorridendo compiaciuto disse rivolto alla moglie: “Non è poi così’ piccolo, ad otto anni io ero già in montagna ad accudire agli agnelli, in ogni caso è tempo che cominci a prendere confidenza con il lavoro del pastore, non dimenticare che abbiamo deciso che non appena termina la quinta elementare lui verrà con me a darmi una mano”, rivolgendosi poi al figlio, così egli concluse: “D’accordo, verrai con me, adesso però finisci la cena e poi vai a letto di corsa, domani mattina ci metteremo molto presto per via”.
Salvo andò a letto, ma come, abbiamo visto dormì poco e male, quando si addormentò profondamente quasi subito fu svegliato dalla madre: era ora della partenza.
– Che ora è? – chiese con un filo di voce.
– L’orologio della piazza ha appena suonato le quattro, sbrigati, papà sta già sellando la giumenta.
Il ragazzo fece davvero prestissimo, lui che solitamente usciva di casa in ritardo per recarsi a suola. In quell’occasione la madre si mostrò più premurosa del solito, Salvo trovò sul tavolo, già pronta, un’abbondante colazione, con uova sode e caffellatte. Ingoiò tutto il fretta visto che nel frattempo suo padre aveva già sollecitato il ragazzo a scendere. Prima di uscire Salvo fu abbracciato e baciato con particolare calore della madre e questo eccesso di premure da parte di lei nei suoi riguardi lo fece sentire particolarmente importante.
Uscì di casa coperto perché a dire di sua madre in tal modo egli sarebbe stato protetto dal freddo gelido che c’era in mattinata. Il padre lo aiutò a montare sull’animale mentre lui prese le redini della giumenta e si avviò per le viuzze del paese.
Salvo quella mattina ebbe modo di scoprire che la vita in paese iniziava molto presto, infatti nel breve tratto di strada che percossero, da casa loro fin oltre le ultime case, là dove iniziava la campagna, incontrarono molti braccianti che intabarrati e con le zappe sulle spalle si avviavano verso la piazza dell’orologio dove speravano che un padrone li avrebbe ingaggiati per qualche lavoro, altri contadini erano in movimento diretti ai campi, con i loro animali carichi degli attrezzi necessari.
Le strade pavimentate con i ciottoli del vicino torrente, risuonavano del rumore degli zoccoli ferrati degli animali, degli scarponi chiodati della gente di campagna, mentre le voci degli uomini si alternavano, mescolandosi a quella degli asini, delle capre, delle giumente, dei galli che proprio in quel momento cominciavano a salutare il nuovo giorno cantando ripetutamente.
Salvo che per la prima volta assisteva a quella manifestazione d’umanità, era affascinato per la varietà di suoni che udiva, vedeva il movimento degli uomini, certamente era uno spettacolo differente, molto più ricco, del rientro serale dei contadini della campagna su cui pure qualche volta aveva soffermato lo sguardo curioso, e notava come allora le genti dei campi ritornassero a casa con il buio, stanchi e frettolose di mettersi davanti ad una minestra calda e fumante.
Fuori dell’abitato uomini e bestie si avviavano per le trazzere, l’occhio ben attento a scansare una pietra, un fosso, una zona fangosa; sembravano tanti serpenti che si snodavano per la campagna nell’oscurità, mentre lontano nell’orizzonte i primi chiarori dell’alba segnavano il momento dell’incertezza, l’equivocità che esiste tra la notte che finisce ed il giorno che ancora deve iniziare. Più avanti le trazzere venivano via via abbandonate dai frettolosi viandanti che imboccavano stretti viottoli per raggiungere gli appezzamenti di terreno o le masserie, ad ognuno di questi crocicchi, gli uomini al momento di separarsi si lanciavano un’ultima battuta, poi tiravano bruscamente le redini degli animali per sollecitarli ad affrettare il passo. Il padre di Salvo, stanco di camminare a piedi aveva chiesto al ragazzo di spostarsi sulla groppa dell’animale cosicché lui era salito in sella. Adesso la giumenta stava affrontando i tornanti di un viottolo che costeggiava una montagna ove si alternavano tratti erbosi a zone aride e più oltre ancora sciare pietrose nel mezzo della quale verdeggiavano le macchie dei rovi. Ogni tanto in perfetta solitudine tra quel paesaggio brullo e deserto si scorgeva qualche albero.
“Strano come in mezzo a quelle pietraie possa crescere un albero così forte e verdeggiante”, mormorò quasi a se stesso il ragazzo.
“Parli di quel “millecucchi”?” Chiese il padre.
“Che strano nome “, commentò l’altro per tutta risposta.
“Strano non direi, a sera, nel buio della notte, fra i rami di quell’albero vengono a posarsi molti uccelli per passarvi la notte, fra essi vi sono alcuni “cucchi” che riempiono la notte con i loro canti; a volte sono tanti che si ha l’impressione che siano cento… mille, da qui credo l’origine del nome che alcuni pastori gli hanno dato”.
Il viottolo adesso passava vicino ad uno di questi alberi, Salvo lo scrutò attentamente nell’ir1tento di scorgervi qualcosa, ma non vide niente, l’albero sembrava abbandonato. Il fogliame fitto, i rami contorti diretti in ogni direzione, davano l’idea di un grande labirinto. Il tronco dell’albero forte e slanciato emergeva tra i sassi dando ai presenti un senso di vigoroso rispetto, di vittoria sulla fredda pietra.
“Papà, ma io non vedo “cucchi” dentro l’albero”. La voce del padre risuonò sicura e paziente.
“Ci sono, ci sono, adesso hanno paura di noi che siamo vicini e poi E l’alba, e loro cominciano a muoversi per andare in cerca di cibo. Vedrai che stasera si faranno sentire”.
Intanto padre e figlio erano ormai nei pressi della masseria, anche se il caseggiato era celato alla vista da un colle, la sua presenza era rivelata dal belare delle pecore impazienti di uscire al pascolo, e dall’abbaiare dei cani che si faceva sempre più insistente all’avvicinarsi dei due. Superato il colle, la masseria apparve per intero agli occhi di Salvo, non che lui non l’avesse mai visto, ma certo in quella stagione appariva realmente diversa. I recinti costruiti con pietre a secco, tenevano al riparo tre greggi di pecore, vicino alle case vi era quello che veniva munto, più in là erano chiuse le pecore che i pastori chiamavano “strippe” vale a dire quelle che non venivano munte ed infine in un piccolo recinto erano chiuse gli agnelli che dovevano essere svezzati. Appena sceso da cavallo, Salvo si mise a correre per ogni dove, spaventando a volte gli animali che andavano a rifugiarsi in un angolo del recinto, pronti comunque a cambiare posizione o a saltare il muretto qualora a loro giudizio l’intruso si fosse avvicinato ulteriormente.
Il ragazzo per l’intera giornata si mosse con il padre, girando per il feudo e curiosando per ogni dove, chiedendo spiegazioni al genitore per ogni cosa, anche la più futile che non riusciva a spiegarsi. A sera, con il ventre pieno d’erba, il gregge si avviava mollemente verso l’ovile per la mungitura, nel frattempo uno zio di Salvo che durante il giorno aveva raccolto un po’ di verdure selvatiche, si apprestava a cucinare un po’ di minestre, le verdure, una patata, un mestolo a testa di pasta come misura, venivano messe nella pentola per essere divisi equamente non appena si cuocevano. Si cenava che ormai era buio fitto, seduti sopra qualche sgabello di fortuna o un ruvido sasso, ognuno dei presenti mangiava la sua minestra con il pensiero rivolto alla famiglia lontana, era il momento più delicato della giornata del pastore, il momento della debolezza e della solitudine. Salvo immerso in quella atmosfera, immergeva lentamente il cucchiaio nel brodo fumante e intanto pensava a cosa stavano facendo in quel momento i suoi compagni di giuochi, probabilmente pensava, erano intenti a giocare alla guerra fra i Vicoli Saraceni. Sentì pizzicarsi dalla nostalgia quand’ecco un canto stridulo e prolungato proveniente da fuori, lo fece trasalire. Suo padre che aveva notato questo suo interesse confermò:
“Proprio così, quello lì che canta è un gufo, adesso vedrai che cominciano”.
Salvo non udì le ultime parole del padre perché era saltato fuori, gli occhi sbarrati al buio nel vano tentativo di scorgere qualcosa. Ecco che da un’altra parte un altro “cucco” fece udire la sua voce, e poi un altro ancora, quegli strani alberi delle sciare sembravano volersi animare, come se essi stessi emettessero quel canto d’uccello …si, erano davvero gli alberi dei millecucchi che ora cantavano in coro per fare arrivare la propria voce alla luna che dietro il monte faceva proprio adesso la sua comparsa. Pure gli animali con le loro voci partecipavano a quel canto della natura e Salvo ad un certo punto volle pure lui esserne parte, si mise a cantare una canzoncina che aveva imparato in sacrestia. Al ragazzo sembrava di sognare, e desiderava che quella notte non avesse più termine, ma la voce del padre venne a spezzare la magia del momento: “Salvo, vieni dentro che è ora di dormire”.
Vergognoso di essersi farro scoprire a cantare al buio, Salvo arrossì, smise, e rientrò nella casupola per andarsi a mettere vicino al fuoco e riscaldarsi.
Tendendo le mani alle braci ormai spente, egli si rivolse al padre: “Avevi ragione, l’albero dei millecucchi è davvero fantastico”, e si mosse per raggiungere il suo giaciglio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Il vento di tramontana proveniente dal mare di Porto Palo, freddo ed instabile, spazzava le stridette diritte e poco illuminate del paese. Era notte ed il buio era ancora padrone delle cose e degli uomini, eppure a quell’ora Menfi era sveglia; gli uomini scendevano nelle stalle per accudire gli animali, dare loro la biada, sellarle, scegliere e mettere pronti gli attrezzi agricoli più idonei per il lavoro dei campi.
Il quelle case piene di miseria, qualcuno dei proprietari, un po’ meno povero degli altri, possedeva una capra o una mucca che a quell’ora provvedeva a mungere inginocchiato sul pavimento tra la paglia e lo sterco degli animali, come in preghiera, perchèp il suo Dio si ricordasse di lui. Stringevano i capezzoli per solerzia e competenza mentre il latte ancora caldo e schiumoso riempiva una povera brocca di coccio, l’animale pazientava emettendo secchi a volte lamentosi richiami che s’innalzavano per l’aria, rincorrendosi fra loro come a seguire gli sbuffi del vento, a tratti più forte del solito.
Le donne menfitane al contrario si davano da fare in cucina per preparare il lato al proprio uomo che lo avrebbe consumato a mezzogiorno durante una pausa del lavoro e mentre gli animali masticavano la loro razione di orzo. Non c’era molto da mettere sotto i denti: quattro olive, una crosta di formaggio, due fichi secchi che dovevano essere divisi tra i molti componenti della famiglia.
Quando il chiarore dell’alba cominciava a rischiarare le cime dei monti in lontananza verso Sambuca, la popolazione di Menfi usciva per strada in grande confusione di uomini, animali, tra il vociare della gente che incontrandosi ai crocicchi tra il tintinnio degli zoccoli si salutava. Gli zoccoli ferrati degli animali, il rumore degli scarponi chiodati dei braccianti che strusciavano sui ciottoli delle strade. In questo caotico vociare subito dopo il tocco dell’orologio della piazza, cominciava ad udirsi in lontananza, sempre più vicina una voce che cadenzava:
Va susitivi chi tardu eni,
va pigghiativi lu café.
Era una voce cantilenante,lenta come i tocchi dell’orologio che battevano le ore, a volte confondendosi con essi. Una voce che come lo spuntare del sole e della luna, il cambio delle stagioni segnava anch’essa il ritmo ed il trascorrere del tempo. Quell’uomo era ù Zu Paulu Marredda, un uomo bonaccione e socievole, dal grande ventre che lo costringeva a camminare con precauzione dondolandosi ad ogni passo. Lui prima degli altri si alzava ogni mattina, preparava una grande pentola di orzo-caffè e dopo averla versata in un grande recipiente, usciva con esso a tracollo tenendo in mano un mestolo come misurino. Il Marredda si inoltrava per le strade che cominciavano ad affollarsi di gente che si avviava al lavoro. Camminava lentamente per dar modo alle donne di uscire di casa per comprare il suo caffé, o ai vari passanti di avvicinarsi per bere un po’ della sua bevanda calda, intanto ritmava il suo invito-sveglia:
Va susitivi chi tardu è
Va pigliativi lu café
Dopo avere percorso le strade principali, con i contadini ormai tutti in campagna, lu zu Paulu si avviava verso la piazza dove rimanevano in disperata attesa molti poveri braccianti con la speranza che qualche proprietario ritardatario passasse di lì per chiamare ancora qualche fortunato, ingaggiandolo nei suoi campi. Il Marredda a quell’ora aveva già venduto gran parte del suo caffé, il resto sarebbe rimasto invenduto nel recipiente dato che gli uomini presenti in piazza non avevano soldi per comprare alcunché, qualcuno più fortunato barattava un po’ di quella bevanda con un pugno di lumache o con qualche cespo di cicoria selvatica, ma intanto il sole splendeva alto sul paese e sulla campagna circostante, sul mare in lontananza si vedevano le barche intente alla pesca. A questo punto la giornata lavorativa del Marredda era finita, aveva assorto al suo compito di orologio ambulante guadagnandosi onestamente il suo pane quotidiano, per cui adesso tornava a casa per riposare qualche ora. L’indomani puntuale ed inesorabile, ancora prima del nuovo giorno sarebbe stato per strada a tirare fuori dal letto colui che avesse dimenticato di svegliarsi per tempo con la sua voce:
Va susitivi che tardu è,
va pigliativi lu café.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
É una storia d’altri tempi, si potrebbe dire che non è mai esistita se non nella fantasia dei soliti maligni, di quei poveracci che da sempre in passato sono corsi dietro un tozzo di pane senza mai poterlo raggiungere.
Una favola che potremmo cominciare con la rituale introduzione: C’era una volta in un paese lontano…
Dunque esisteva una città molto grande che si chiamava Palermo, i suoi abitanti erano per la gran parte molto poveri e la loro condizione socio-economica tanto miserevole da fare da contraltare alla ricchezza sfacciata di pochi nobili che per tanto si sentivano in diritto di lasciare morire i propri simili senza alcun rimorso di coscienza. In questa città esisteva pure una casta di privilegiati che il popolino chiamava “Parrini”, essi accudivano alle cerimonie del culto, ed all’ombra dei sacri templi si davano da fare per arricchirsi, sfruttando anche la miseria della gente.
Fin dai tempi più remoti, il clero locale aveva pensato bene di costruire accanto agli edifici del culto religioso delle torri d’osservazione che avevano mimetizzato alla vista dei presenti, facendoli passare per campanili, ma in effetti li utilizzavano come osservatori esclusivi e privilegiati per poter controllare meglio ogni più piccolo spostamento della popolazione locale. Dunque in questa città, accadde che dopo una grave e disastrosa guerra che i più chiamarono mondiale, gran parte della popolazione, già povera, si ridusse in uno stato di totale miseria, per cui perso ogni avere e non trovando lavoro alcuno, in molti andarono a vivere all’addiaccio fuori le mura della città. All’alba, come un esercito di parassiti di biblica memoria, essi entravano in città e bussavano timorosi di porta in porta per chiedere un tozzo di pane:
“ Faciti la carità Signuria”, chiedevano lamentosi, “, “Un pezzu di pani pi nun moriri di fami”.
Ma quasi sempre i portoni delle abitazioni rimanevano ermeticamente chiusi, qualcuno raramente rispondeva:
“Aviti bontà, bon’omu”, ma di pane neanche a parlarne.
Questo andazzo non sfuggì ai preti della città che si riunirono in Gran Consiglio per discutere del problema e decidere eventualmente come sfruttare tutta la faccenda, e utilizzarla per il proprio tornaconto. Discussero a lungo, spesso litigando, ma alla fine tutti concordarono per una linea comune. Convocarono tutti i poveri della città e dissero loro:
“È inutile andare a chiedere il tozzo di pane che vi serva per sfamarvi, così come fate rischiate di morire tutti per fame, nessuno in città è disposto a darvi qualcosa, ma noi abbiamo il grimaldello per aprire le loro porte e vi suggeriamo un sistema sicuro per costringere i benestanti locali a farvi l’elemosina. Naturalmente il ricavato sarà diviso in parti uguali: la metà a voi ed il resto alla chiesa che vi organizzerà”.
Detto fatto i poveri furono divisi per rioni, ad ognuno di essi fu data un’icona (una sorta di cassetta con l’effige di un santo incollata sopra) e con essa addosso il mendicante questa volta bussava alle porte con spavalderia e vigore: “Faciti la limosina a lu Santu Patri, iu cogliu pi San Giseppi.
Dunque da questo momento i poveri di Palermo presero a chiedere la carità per conto di un santo ed il risultato non poteva che essere decisamente positivo. In questa grande città la popolazione benestante era terribilmente bigotta, fedele in modo particolare ad un santo, passando nella zona le varie icone, ogni uno apriva la porta di casa e divideva il suo pane con il mendicante.
Con il tempo i preti cominciarono ad organizzare meglio il passaggio dei poveri per le strade onde evitare che alcuni di essi passassero nella stessa strada con il risultato di ottenere una questua insufficiente alle aspettative. Purtroppo dopo qualche tempo ci si accorse che nel progetto originario qualcosa non andava per il verso giusto, il pane che spettava al clero riempiva le sacrestie senza che esso potesse essere mercificato in alcun modo. Nuova riunione dei preti per risolvere il problema per cui nacque la nuova icona con la fessura e con l’unica chiave per aprirla ovviamente in possesso dei preti i nuovi patti fra questuanti e religiosi furono subito stilati. Da quel momento i soldi della questua sarebbero stati incassati dai preti mentre tutto il pane raccolto sarebbe andato ai poveri. Ancora una volta il risultato fu soddisfacente per entrambi le parti. I poveri poterono finalmente sfamarsi ed i preti con i soldi delle icone cominciarono ad accrescere il loro tenore di vita: a comprarsi il formaggio, un po’ di carne, qualche comodità per le loro case.
Ma i preti, maestri d’inganni, erano per natura sospettosi, per cui diffidavano per principio dei loro simili. Allo scopo di prevenire ogni possibile frode registravano giornalmente l’incasso di ogni icona del santo. Da quì si erano resi conto che le anime buone di Palermo quotidianamente versavano il loro obolo al loro santo protettore. I poveri notavano con sempre crescente invidia che i preti, anche grazie al loro quotidiano lavoro, cominciavano a mostrarsi ben coloriti in viso, ad ingrassarsi e presero a sperare qualcosa di più, diciamo del loro lavoro. Uno di essi, più intraprendente degli altri, decise per suo conto di tenersi per se parte del denaro della icona. A quei tempi tutta la popolazione portava in tasca un coltello, esso serviva per tagliare il pane durante il pasto, come pure a raccogliere le erbe commestibili o le radici che in molti mettevano in bocca nella speranza di stordire la fame. Ebbene questo intraprendente poveraccio nel chiuso del suo tugurio, dopo avere immerso il coltello nella soda caustica, fece passare la lama d’acciaio attraverso la fessura. Le monetine grazie alla soda si attaccavano al metallo e venivano fuori. Per quella volta il nostro uomo decise di sottrarre cinque monetine. E con il frutto del suo peccato in tasca l’uomo si avviò verso la chiesa per consegnare il ricavato della sua fatica quotidiana. Il religioso all’atto di intascare il denaro si accorse che insolitamente quella sera mancavano cinque monetine e mangiata la foglia volle giocare d’astuzia per cogliere in anticipo il furbastro. Come per ubbidire ad un comando divino lasciò il cassetto e si diresse verso l’altare dove troneggiava un grande crocifisso in legno. Stette in meditazione qualche minuto, seguito dal comprensibile sguardo del mendicante, poi ritornò sui suoi passi. Lo sguardo ansioso, il prete aveva un’aria studiatamente triste, la voce risuonò carica di dolore: “Pippinu – disse con gesti accorati, _ nun ti pari malu a rubbari cinqu sordi a lu Signuruzzu?”.
All’uomo caddero letteralmente le braccia, preso da comprensibile timore per essere stato scoperto, si buttò carponi per terra e chiedendo perdono a Dio del suo malfatto, restituì le cinque monete illecitamente sottratte dalla icona. Più tardi parlando dell’accaduto con i suoi amici, l’uomo confidò che quel prete parlava con Dio, per cui consigliava gli altri di non rubare i soldi della questua che lui se ne sarebbe accorto. Per qualche tempo il pericolo della sottrazione del denaro destinato alla chiesa fu scongiurato, ma i tempi cambiavano ed anche la miseria cominciava ad essere meno totalizzante, allo scopo di supplire alle carenze degli elemosinanti, i preti, ancora una volta nel loro Gran Consiglio, decisero di cambiare le loro icone, da ambulanti in fisse presso le chiese stesse, con lapidi che portavano delle incisioni per convincere i fedeli della necessità di ottemperare a tale richiesta, nel marmo inoltre veniva aperta una piccola fessura ove veniva introdotta la monetina.
Più avanti ancora il solito Consiglio, adeguandosi prontamente all’evoluzione dei tempi, continuò a chiedere soldi ai poveri cittadini di Palermo, entrando addirittura in tutte le case con un marchingegno che tutti già chiamavano con il nome di: Radio. Nessuno di loro purtroppo riuscì a capire che quello era il più terribile poliziotto che il potere aveva inventato dalla notte dei tempi, ma tanto, ai più la cosa non interessava. Il nuovo marchingegno piaceva e faceva divertire tutti per cui le offerte fioccavano ancora più copiose.
Alla fine della nostra favola possiamo concludere come il vecchio saggio e con l’Anticu dicemu: “E iddi ristaru filici e contenti e nautri cca senza nenti”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
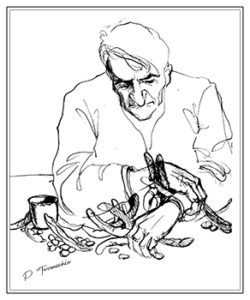 La strada era stretta e priva di marciapiedi, i rari passanti che la percorrevano camminavano tra mille difficoltà, a volte sfiorati dalle macchine che in quella zona avanzavano a velocità sostenuta, spesso rendendosi pericolose. D’inverno poi, dopo i violenti acquazzoni, sembrava che gli uomini alla guida delle macchine provassero un insolito piacere ad accelerare i loro mezzi nei pressi delle tante pozzanghere d’acqua fangosa che abbondavano nella strada, tanto da schizzare fin sopra i capelli dei malcapitati che per qualche necessità si trovavano a percorrerla
La strada era stretta e priva di marciapiedi, i rari passanti che la percorrevano camminavano tra mille difficoltà, a volte sfiorati dalle macchine che in quella zona avanzavano a velocità sostenuta, spesso rendendosi pericolose. D’inverno poi, dopo i violenti acquazzoni, sembrava che gli uomini alla guida delle macchine provassero un insolito piacere ad accelerare i loro mezzi nei pressi delle tante pozzanghere d’acqua fangosa che abbondavano nella strada, tanto da schizzare fin sopra i capelli dei malcapitati che per qualche necessità si trovavano a percorrerla
La via si trovavalontana dal centro della città, un tempo era in piena campagna ed essa era solamente una stretta trazzera che disimpegnava due fondi rurali molto ampi. Attorno a questa antica via con il tempo erano nate alcune casupole costruite alla meno peggio dai contadini che lavoravano i terreni vicini, in seguito alle pressioni fatte sui politici locali, gli amministratori acconsentirono a trasformare quella strada sterrata e vi apposero un manto d’asfalto, da quel momento la gente della zona ebbe l’illusione di appartenere alla grande città ormai vicina. Le facciate delle povere case vennero rifatte con qualche abbellimento; un portantino pretenzioso, un muro rifatto a calce, un balcone ornato con qualche vaso di menta e basilico, la stessa via venne intitolata con il nome di un martire della guerra d’Africa, chi poi fosse in realtà quel soldato che ebbe la pessima idea di farsi trucidare dagli abissini nessuno dei locali ebbe a saperlo, né alcuno di loro si era dato da fare per conoscerlo.
La via in questione era abitata da contadini che ricavavano il sufficiente per vivere coltivando piccoli fazzoletti di terra ad orto, i prodotti del quale gli stessi produttori vendevano, andando ignoro per le vie della città, altri ancora erano vaccari che per alimentare le proprie bestie andavano giornalmente nei mercatini rionali a caricare sui propri mezzi i rifiuti di cavoli, di lattughe, ecc. ecc., che si ammonticchiavano agli angoli delle strade, spesso questi uomini erano costretti a litigare tra loro quando gli alimenti essenziali per i propri animali erano insufficienti, o anche era la protezione del padrino del luogo a favorire alcuni a scapito di altri.
Gli anziani della strada, quelli non più idonei ai lavori pesanti, ogni mattina inforcavano delle vecchie biciclette per consegnare ai clienti il latte appena munto, spesso diluito con acqua per venire incontro alle molte richieste.
Adesso questa antica via cittadina veniva minacciata nella sua esistenza visto che la campagna attorno ad essa si andava assottigliando ogni giorno di più, inghiottita dall’espansione edilizia che proprio in quella zona si era abbattuta impietosa e selvaggia. SI costruiva a casaccio, un palazzo qui, un altro più avanti, ma intanto questi casermoni moderni a dieci piani cominciavano as alzarsi minacciosi sulle povere case che sempre di più, agli occhi dei proprietari, apparivano quello che esse in realtà erano: delle misere casupole costruite alla meno peggio allo scopo di riparare dalle intemperie alcuni poveracci. Qualche abitante della zona che nel corso degli anni era riuscito a mettere qualche soldo da parte, aveva ristrutturato la propria abitazione dandogli un aspetto piacevole, ma alcune di esse, abbandonate, erano presto diventate il regno dei bambini, dei loro giuochi e delle prime scoperte della loro precoce sessualità, un ottimo rifugio per topi ed insetti di ogni tipo.
Una delle case più vecchie della strada era occupata da un agricoltore, uno dei pochi della zona che non aveva fatto fortuna con il proprio lavoro, adesso era un vecchio irascibile, il volto scavato da mille rughe lasciava intravedere all’occhio del curioso una vita passata sta gli stenti, sotto il sole cocente d’estate, o sferzato dal freddo gelato della tramontana d’inverno, sempre a lavorare quella terra che gli si mostrava ostile dove il gelo o la mancanza delle piogge gli impedivano di ottenere un buon raccolto.
Contrariato per questi dispetti della natura, il vecchio aveva preso il vizio di bestemmiare il suo Iddio, sperando a volte nella sua reazione, ma nessuno dei suoi desideri si potè avverare. Il divino continuò a mostrarsi assente negli affari dell’agricoltore che col passare degli anni si fece sempre più vecchio ed inabile al duro lavoro dei campi. Un bel giorno l’uomo si convinse a lasciare il suo campo e smise di eseguire i lavori pesanti, dietro la propria casa possedeva qualche centinaio di metri quadri di terra e nelle belle giornate di sole, quando il caldo faceva rifluire nelle sue vene un po’ di energie, egli prendeva il suo vecchio attrezzo da lavoro e zappava la terra. L’uomo aveva una particolare passione per le fave verdi e puntualmente a novembre seminava quelle leguminose nel terreno dietro casa.
Ad aprile, con il ritorno del bel tempo, il nostro uomo si sedeva davanti alla porta di casa e si disponeva con particolare gioia ad assaporare il frutto del suo lavoro: pane e fave fresche.
Esisteva un piccolo muricciolo che separava la casa del contadino dalla strada, l’uomo posava su di esso una manata di fave, un coltello, un pezzo di pane ed un bicchiere di lamiera zincata pieno di vino. Con il coltello tagliava il pane a pezzetti piccolissimi che portava alla bocca assieme alle fave sbucciate, gli involucri aperte, ma ancora interi li andava posando poco lontano dagli altri, uno dopo l’altro in ordine e perfettamente allineati, ogni tanto tirava un sorso di vino per facilitare la discesa del cibo nello stomaco ed intanto volgeva lo sguardo spento all’amico sole che con i suoi tepori gli riscaldava le ossa, fugando da esse i residui dolori invernali.
Casualmente, se in quei momenti qualcuno passava vicino la casa del nostro uomo, disturbando quei momenti di grande religiosità individuale, egli, appena accennava ad un saluto, alzando la mano come si usava in altri tempi che i malevoli a volte equivocavano, spesso muoveva le labbra come se al gesto volesse far seguire qualche parola, ma dalla bocca non usciva alcun suono mentre le mani continuavano ad allineare bucce di fave il cui biancore interno veniva a mischiarsi ed a spezzare il verde carico così strano ad ammirarsi sopra quel vecchio muretto scalcinato.
.
.
