POESIE
CELLARO – SOLLAZZO DEL PADRONE – FILIPPO – PUTTANA SORTE – SCHIAVI – GIUMMARA – PEPPINA E GENO – MISILBESI – MADRE – 15 GENNAIO 1968 – ACCURSIO MIRAGLIA – GRAMIGNA
Note biografiche
Angelo Pendola è nato a Sambuca di Sicilia il 4 gennaio 1952. Giornalista pubblicista, collaboratore del Giornale di Sicilia dal 1984.
Ha scritto per il Trapani Nuova, Trapani Sera, La Voce di Sambuca, Lo Studente, Arca News, Arce News Monitor, Il Belice. Ha diretto il mensile Cronache di Menfi. Nel 1983 ha pubblicato la raccolta di poesie Zabut con introduzione a cura di Nat Scammacca e prefazione di Pietro Billeci. Sue poesie sono inserite in antologie italiane ed estere e tradotte da Papp Arpad in ungherese, G.H- Aufrère in francese, Ignazio Buttitta in siciliano, Alexandru Caprariu in romeo o, Fivos Delfis, Panos Miserlis e Kostantin Nikas in greco, Nat Scammacca in inglese.
Nel 1990 ha pubblicato la raccolta Poesie per i romeni.
La silloge è impreziosita da un saggio introduttivo e dalla presentazione dello scrittore Cesare Ser,menghi: dalla postfazione della poetessa-scrittrice Angela Scandaliato: dalle traduzioni a fronte e da molte illustrazioni e disegni: e da notazioni critiche di autorevoli addetti ai lavori, quali: Giorgio Barberi Squarotti dell’Università Torino: Giuseppe Zagarrio: Giorgio Santangelo dell’Università di Palermo; Solange de Bressieux; Oliver Friggieri dell’Università di Malta; Armida Marasco dell’Università di Lecce; Leonardo Patanè dell’Università di Catania, ed altri.
Il ricavato è stato devoluto ai bambini romeni tramite la Caritas Italiana.
Il 1997 lo vede finalista alla XV edizione del Premio Firenze con la seguente motivazione:
“L’ansia di giustizia sociale e di amore universale che pervade quasi tutti i suoi versi, si irradia in una simbologia psicologica che confluisce in una struggente meditazione”.
Nel 1998 gli è stato assegnato a Roma, nella Sala degli Angeli di Palazzo Barberini, il Premio internazionale FRONTIERA per la poesia inedita Sarajevo, e conseguentemente insignito della medaglia Città di Palermo, dal sindaco Leoluca Orlando.
Nell’autunno del 1999 viene invitato alle “Serate di Poesia” che si svolgono in Grecia, ad Argostoli e Lixouri, nella stupenda isola di Cefalonia, per l’occasione è stata presentata la breve raccolta in lingua greca Kefallonias.
Il mio canto
possa raggiungere
i proletari che lottano ovunque
e in questa mia terra “dolcedolente”.
.
Il mio canto è senza tempo,
coglie nello spazio dei soprusi,
nella storia d’un Popolo infelice.
Il mio
è il canto del bambino malmenato,
di chi non sa trovare la ragione,
di chi anziché le braccia
offre il cuore.
É il canto senza pretese,
che non vuole chissà che,
ma che a memoria grida
le “offese”.
PRESENTAZIONE
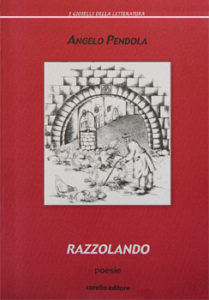 Chi ha letto Zabut di Angelo Pendola non può non avere avvertito quella dolce musicalità, quello splendido lirismo e quel voluttuoso immaginario che si trovano nei poeti arabi Ibn Hamdis e Abdar Rahman. Lirismo e immaginario, sentiti in un diverso contesto storico, culturale e umano, si riscontrano in Razzolando, dove la pena di vivere ha la sua parte come in questi versi di Cellaro: “Giorni bui si accavallano/uno dietro l’altro/ senza speranza/ per noi misere cose…”.
Chi ha letto Zabut di Angelo Pendola non può non avere avvertito quella dolce musicalità, quello splendido lirismo e quel voluttuoso immaginario che si trovano nei poeti arabi Ibn Hamdis e Abdar Rahman. Lirismo e immaginario, sentiti in un diverso contesto storico, culturale e umano, si riscontrano in Razzolando, dove la pena di vivere ha la sua parte come in questi versi di Cellaro: “Giorni bui si accavallano/uno dietro l’altro/ senza speranza/ per noi misere cose…”.
La corda che muove il cuore di Pendola è la triste e dolorosa consapevolezza che su questo mondo umano, su questa umanità pesa come cappa di piombo l’arbitrio e alligna la prepotenza Enza padronale.
La lirica Sollazzo del padrone si conclude con una sentenza di infamità: “Mia figlia/ era bella come il Sole…/ e la vidi pian piano/ consumarsi/ lentamente/ sfiorire,/ sollazzo d’ogni tempo/ d’un infame signorino”.
Quanta diversità di vita tra il povero e il ricco, al primo la miseria offre “…neanche un uovo sodo./ Una minestra/ di cicoria o di borrane/ e un po’ di pane…/ …vitto quotidiano/ di miseri schiavi/ di un padrone sazio/ mai mortificato”.
In questo stato di miseria penosa si erge la figura del padre, che consuma l’esistenza nel nuovo lavoro, nel vento gelido, ma che, malgrado la fatica e la vita grama, non viene meno al sorriso. Il sorriso è l’unica nota benevola, accogliente, consolatoria fra tanta povertà, stanchezza e sofferenza.
Quando scorro le poesie di Razzolando sento che il climax è la voglia del pendola di fuggire, di correre verso un porto quieto, verso un orizzonte solare: “non so più che cosa fare/ rivendo pesce per non rubare”.
Ecco il porto quieto, quella coscienza morale che richiama a far del bene a chi soffre, a prodigarsi per lenirgli il dolore, ad offrire un tozzo di pane a chi ha fame.
Questa miseria del vivere non riscatta speranze, che si infrangono sul muro della mafiosità come motiva la poesia dedicata ad Accursio Miraglia: “Lottare…/ provassi di tutto…/ perfino dell’affetto/ dei miei cari./ Lasciati/ troppo preto/ a un destino incerto”.
Alla guerra, quale funesta insalata di uomini, leva il giro della maledizione il Poeta in Sarajevo: “Sarajevo/ grido di dolore/ del Duemila/ che penetra/ pure le montagne/ e non le coscienze”.
E con alto asenso doloroso così definisce la guerra” “…notte improvvisa/ lamento eterno/ pace perduta/ inferno umano/ che rotola/ nel vuoto/ senza fine./ Sarajevo”.
Su questa condizione di male e di orrori s’accampa il pensiero vibrante degli affetti familiari, del paese natio, della Sicilia solatia, del suo mare, della sua gente “stanca…/ e si accontenta/ di poco/ e non vuol/ mnanco più vedere/ pensare/ lka mia gente”. Su questa situazione di violenze, sul calpestare l’uomo giusto e onesto “A nulla/ serve il pianto/ se non lava…” cioè se non diviene preghiera rivolta alla clemenza di Dio, che opera il perdono. Con questi versi, che richiamano il perdono di Dio, si chiude Razzolando nella fiducia dell’avvento di una umanità redenta dai sentimenti di bontà, di fratellanza, di rispetto reciproco.
Credo opportuno soffermarmi brevemente sul linguaggio di Razzolando, il cui pregio sta nella chiarezza e nella spontaneità grazie alla scelta del verso breve, che liberato dal discorsivo, trova la sua pregnanza nella qualità della parola pura, essenziale, significante, la parola poetica, che dà forza e vitalità alle immagini.
A conferma di quanto detto sul linguaggio riporto due esempi: “Più che una casa/ era un tugurio/ la fame si scopriva/ in ogni muro” (Peppina e Geno).
“Trattata/ sempre come oggetto/ non conobbe mai l’amore/ né l’affetto” (Saruzza)
Castelvetrano, febbraio 1999
Gianni Diecidue
POESIE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giorni bui si accavallavano
uno dietro l’altro
senza speranza
per noi misere cose
in balia si soprusi
e di volgari voglie padrone
umilianti fino al midollo osseo.
Ma non parola poi
un gesto
che prima ci aveva distinto.
L’assenza totale
in un contesto disumano
dove i lupi
avrebbero avuto pietà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mia figlia
era bella come il Sole
l’amavo come nessuno può amarsi
la guardavo
come il più prezioso dei beni
e la vidi piano piano
consumarsi
lentamente
sfiorire
sollazzo d’ogni tempo
d’un infame signorino..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quando venni a saperlo
che il padrone
aveva usato mia figlia
come donna da bordello
fui preso dall’ira giovanile
e dalla tentazione
di strappargli
assieme al cuore
anche i miseri coglioni.
Ma poi sopraggiunse
lo sconforto dell’anziano
che subì tutta la vita
da castrato.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mio marito
non lo vedevo da Natale
e quando scese giù
per la festa grande
dopo circa cinque mesi
mi trovò come un pallone
al quarto mese.
Si girò dall’altro lato
e pianse tutta la notte
maledicendo la nostra scena
e la puttana sorte
il lavoro
e tutte le volte
che aveva mandato
il padrone
a portarmi le ricotte.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
La sera
dopo un giorno
di duro lavoro
per cena non trovavo
neanche un ovo sodo.
Una minestra
di cicoria o di borrane
e un po’ di pane
era tutto quello
che mia moglie
mi potesse dare.
Ci sedevamo attorno
al tavolo tondo
al lume di una
lampada a petrolio
la cipolla intingevamo
in aceto e olio.
Era il nostro vitto quotidiano
di miseri schiavi
di un padrone sazio
mai mortificato..
TORNA SU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Da far rabbrividire
e chiamare tutti i santi
tuoni e lampi a profusione
e tant’acqua nel vallone.
Da novembre fino a Pasqua
non smetteva quasi mai
giorni lunghi
e notti fredde
senza cibo a sufficienza
si chiedeva a Dio
clemenza.
Non si poteva metter fuori
neanche il naso
per andare a svuotare
in tutta fretta
la stracolma seggetta.
Ce ne stavamo
grandi e bambini
uno accanto all’altro stipati
fino alla sera dalla mattina
a lavorare la provvida curina (2)
unico sostentamento
per noi poveri pezzenti
la cui fame
non fu mai latente.
1- palma nana
2- foglie centrali-più pregiate – della stessa pianta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Più che una casa
era un tugurio
la fame si scopriva
in ogni muro.
Le crepe reran
tante e vistose
tane per topi
e blatte schifose.
Andavo a muratore
per un pezzo di pane.
I miei genitori
prendevano la via
della montagna
se non era buio
non facevano ritorno.
La loro fatica
quando andava bene
fruttava più del mio mestiere.
Ma i capperi
non ci facevano
diventare ricchi
restavamo sempre
con un pugno di mosche.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Per me
in tutti questi anni
nulla è cambiato
come per tanti.
Mi siedo ogni mattina
fuori ad aspettare
che qualcuno mi venga
a prelevare.Mi fanno salire
a cassettone
con il freddo
o con il sole.
Lavoro e mi tiro
il filare
senza mai parlare.
Una volta che lo feci
che volevo tirarmi le difese
il padrone
davanti a tutti
mi prese a schiaffi:
“Prenditi questi
e vieni per gli altri”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Se tu sapessi
quanto mi è costato
farti venire al mondo
figlio mio.
Avevo dato ascolto
a quegli occhi belli
creduto che fosse
come il mio
amore vero.
M’abbandonò
dopo che mi fece sua
notte e giorno:
in casa li ritrovai
tutti contro.
Volevano che abortissi…
Che poi ti dessi…
lottai fino in fondo
perché tu nascessi.
Fuggimmo via lontano
e patii di tutto
ma non t’abbandonai, no!
non era giusto.
Ora mi ritrovo
vecchia e sola
il tuo sorriso
è per un’altra signora.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mio marito
andava a lavorare i campi
io mettevo da parte
i miseri risparmi.
Con quelli
avrei dovuto fare
la dote alla bambina
che ad ogni dì
era sempre più carina.
Di tanto in tanto
un letto una coperta
quel che potevo
era questo che a Dio chiedevo.
Null’altro avrei desiderato
se non d’andare avanti
fino in fondo
e passare poi tranquilla
all’altro mondo.
Ma la terra
fu devastata
quella terribile nottata.
Persi la roba
e la mia bambina
che intanto s’era fatta
signorina.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ne valeva la pena?!
Lottare…
privarsi di tutto…
perfino dell’affetto
dei miei cari.
Lasciati
troppo presto
a un destino incerto.
Ho perso l’ardore
la vita e l’amore;
quell’amore che mi legava
alla mia gente,
alla mia famiglia,
a Nico
povero innocente…
Si!, nw valeva la pena!
Ora ne sono certo.
Continua a pagare
chi infido colpo
m’ha inferto
alle spalle
e al petto.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Non c’è scampo
per noi di quaggiù
il cambiamento non ci sarà
niente e nessuno
può governare
questa barca
che naviga male.
Questa è la terra
dei nostri padri
fatta di pene
di rovi e di mafia
questa è la terra
che non ha speranza
qui la gramigna
è in abbondanza.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
